Lottare per un sogno: intervista a Negasi Haylu Abreha
Il 14 di ottobre, con le ultime gare della stagione oramai andate o in procinto di concludersi a diverse latitudini più ad est, su X (quello che una volta si chiamava Twitter) è piuttosto facile imbattersi in messaggi di ciclisti e cicliste alle prese con il tirare le somme di tutto l’asfalto passato sotto le proprie ruote nei molti mesi precedenti. Invece, quel giorno, assieme ad altre circa 432mila persone nel corso del tempo, mi sono imbattuta in una richiesta di aiuto. A scriverla era l’attuale campione nazionale etiope, Negasi Haylu Abreha. Specificava, subito dalle prime righe, che in realtà sarebbe anche un corridore per la Q36.5 pro team ma solo fino alla fine dell’anno, almeno così gli era stato comunicato. Un agente non lo ha mai avuto e nel frattempo molte squadre avevano finito di stilare il roster per la prossima stagione. Così ha deciso di optare per un messaggio in una bottiglia virtuale, lui naufrago con il sogno di poter regalare all’Etiopia quello che Biniam Girmay è riuscito a regalare all’Eritrea, scrivendo la storia del ciclismo africano. Sottolineava anche il quarto posto agli appena disputati campionati continentali africani, consapevole che sarebbe potuta andare meglio, ma che a lui bastava. Finiva il thread con un account di posta elettronica a cui scrivere oppure il consiglio di infilarsi nei suoi DM su Instagram, come direbbero quelli più giovani di me. Nessuna implorazione, ma un’implicita speranza che nel mucchio di persone annoiate alle prese con lo scrollare ci fosse quella disposta a dargli una seconda chance.
Fino a quel momento di Negasi non sapevo nulla, come succede alle storie che finiscono in fondo al peloton e alle classifiche delle gare, e anche quando ho finito di leggere quel thread continuavo a saperne veramente poco. Qualche minuto dopo potevo raccontare ad uno sconosciuto, grazie ad una ricerca su internet, che è nato il 9 maggio del 2000 a Mek’ele, una città a 2.250 metri di altitudine che fa da capitale alla regione etiope del Tigray; che parla il Tigrinya e l’Amharic ma anche un po’ di inglese e italiano, grazie agli anni con base a Lucca; e che tra il 2020 e il 2023 ha forse vissuto uno dei momenti peggiori della sua vita, quando è scoppiata una guerra civile tra il Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray (TPLF) e il governo federale etiope, appoggiato dall'Eritrea e dai militanti della regione confinante dell'Amhara. Negasi sarebbe dovuto tornare a casa alla fine del 2020, invece per cinque mesi da casa non ha ricevuto notizie. L’unica cosa che sapeva è che migliaia di persone continuavano a morire e a lui, distante ed impotente, non restava altro che aspettare un messaggio o una telefonata, facendo la cosa che conosceva meglio, forse quella che l’ha salvato più di tutte: pedalare. Fino al 2022 lo ha fatto prima per il NTT Continental Cycling Team, poi per il team Qhubeka. Ha corso in diverse gare U23 come il Tour de l’Avenir e quello che oggi conosciamo come Giro Next Gen, ma anche il Giro di Sicilia e il Tour of Britain. Ci sono voluti tre anni prima che riuscisse a riabbracciare sua madre e i suoi fratelli.
Ho provato per giorni a non pensare a quel tweet: era tra le cose più umane e più vere sul ciclismo in cui mi fossi imbattuta sui social da quando ho cominciato a seguire questo sport. Così ho aperto Instagram, ho cercato il profilo di Negasi e gli ho chiesto se aveva voglia di raccontarmi cosa stesse succedendo nella sua vita.
Avrei voluto chiedertelo come ultima cosa, ma penso che forse sia giusto aprire così quest’intervista, piuttosto che cominciare, come farei di solito, dal passato: hai qualche novità sul tuo futuro? Sei stato contattato da qualche agente o da qualche squadra per il prossimo anno?
Qualcuno mi ha contattato per chiedermi cosa potesse fare per aiutarmi, ma senza risultati. Il primo giorno, ad esempio, un agente, che solitamente si occupa di calcio, mi ha scritto dicendomi che avrebbe voluto cominciare a rappresentare anche ciclisti e che aveva già cominciato a farlo per un corridore, dunque avrebbe provato a fare lo stesso anche per me. Mi ha fatto alcune domande e chiesto dei documenti come il mio CV ma non credo che riuscirà ad aiutarmi.
Cerco di riportarti allora - spero! - verso momenti più felici: ti ricordi quale è stata la prima volta che sei salito in sella ad una bici?
Solitamente in Etiopia, nella mia regione, c’è una gara ogni domenica. Si corre vicino casa mia, perciò è stato facile innamorarmi di questo sport. Ho chiesto ai miei genitori di poter comprare una mountain bike: mio padre era d’accordo, mia madre lo era decisamente meno (ride). Era spaventata dal fatto che spesso vedeva i partecipanti alle gare vicino casa nostra cadere e farsi male. Alla fine mio padre mi ha dato i soldi per poterla acquistare e ho cominciato a pedalare. Inizialmente l’ho fatto per un team locale che mi forniva vitto, alloggio e anche una bici, ma non poteva pagarmi. Ero troppo giovane per loro, ma dopo circa tre mesi di allenamento hanno cambiato idea e hanno cominciato a farlo. La mia prima gara in Africa è stata in Algeria con il team nazionale etiope, quando avevo 19 anni. Poco dopo, nel 2019, sono stato per tre mesi in un training camp presso il centro dell’UCI in Sudafrica, a Città del Capo. Nel luglio dello stesso anno sono tornato a casa, in Etiopia, per i campionati nazionali e sono riuscito a diventare campione nazionale del mio Paese. Quella vittoria mi ha permesso di ottenere un contratto per venire finalmente in Europa. Sono arrivato a Lucca alla fine di luglio del 2020. A novembre, il giorno prima che partissi per tornare a casa, è scoppiata una guerra civile nel mio Paese. Per tre anni e mezzo non sono riuscito a rimettere piede in Etiopia.
Hai ancora in Etiopia quella prima mountain bike?
Certo! Ha cominciato a muovere i primi passi nel ciclismo anche mio fratello e si è allenato con quella bicicletta, nonostante fosse un pochino grande per lui. Ne ha acquistata una nuova, anche se nel frattempo è entrato a far parte di un team. Mia madre, in compenso, non è più spaventata come una volta, anzi mi supporta seppur non comprenda molto del mondo del ciclismo: era a dir poco scettica quando le raccontavo che volevo correre fuori dall’Etiopia e venire in Europa a farlo, credeva non fosse possibile.
Ci sono ciclisti dal passato o che appartengono al presente che ti ispirano?
Molti ciclisti che correvano con me in Etiopia, quando è scoppiata la guerra, si sono uniti ai combattimenti e, ora che è finita, hanno ricominciato a pedalare nonostante il ritorno alla normalità sia piuttosto lontano. Alcuni, invece, nella guerra hanno perso la vita.
Quanto è stato importante il ciclismo per te quando è scoppiata la guerra nel tuo Paese e non avevi modo né di farvi ritorno, né di sapere come stesse la tua famiglia?
Quando è scoppiata la guerra in Etiopia, è stato chiuso tutto e non potevo contattare la mia famiglia. Per riuscire a mandarmi un messaggio, mio fratello era costretto a recarsi in un’altra regione da cui poteva finalmente inviarmi un vocale di pochissimi secondi, che doveva comunque pagare. Cercava di dirmi che stavano bene e che non dovevo preoccuparmi per loro. Ero nervoso perché volevo aiutare loro e altri che mi avevano chiesto aiuto, ma non era facile mandare soldi: se provavo ad inviare alla mia famiglia circa 2.500 euro, dovevo mandarli per prima cosa nella capitale dell’Etiopia e da lì dovevano compiere un viaggio da regione a regione prima di arrivare alla mia; alla fine la mia famiglia, viste le commissioni che ogni regione richiedeva, riceveva non più di 350 euro. Mentre ero a Lucca e mi allenavo, mi sono cominciato a chiedere per cosa lo stessi facendo. Non sapevo nulla della mia famiglia, vedevo solo notizie di persone che avevano perso la vita, scrollando su Facebook e temevo che un giorno potesse comparire il nome di qualche mio caro.
Immagino che le differenze tra il ciclismo in Etiopia e quello in Europa siano tante, ma c’è qualcosa che ti ha impressionato più di altre quando sei arrivato a pedalare qui?
Ce ne sono veramente tante! (ride)
La prima volta che sono arrivato qui, nel 2020, facevo fatica con tutto: non conoscevo l’inglese o l’italiano, non capivo molto di quello che mi veniva detto e mi capitava spesso di fare errori all’interno del team perché non conoscevo le regole. Tutto è stato uno shock per me il primo anno. In Etiopia, ad esempio, così come in Africa, le gare e i loro percorsi non sono così duri come qui in Europa.
Qual è il tuo ricordo più felice fino ad ora?
Nel 2019, quando ho vinto il titolo di campione nazionale etiope. Mi ha cambiato la vita. Prima di andare, ero nel centro UCI in Sudafrica, avrei dovuto continuare per un altro mese e uno dei manager mi aveva sconsigliato di partecipare perché mancavano veramente pochi giorni alla gara e non riteneva che ce l’avrei mai fatta a vincere: la gara era troppo dura e per giunta in altitudine. Secondo lui, avrei solo perso i soldi di un viaggio a vuoto. Ho chiamato il mio coach in Etiopia e gli ho detto che volevo partecipare ai campionati nazionali. Anche lui era piuttosto sorpreso e credeva fosse una follia. Avevo 19 anni, mi sono detto che non mi importava nulla dei soldi, volevo e dovevo provare. Quando ho raggiunto il mio team in Etiopia, il mio coach era così arrabbiato che si rifiutava di parlare con me. L’unica cosa che è riuscito a chiedermi, urlando, è perché fossi andato. La prima gara è stata la cronometro individuale, alla quale non ero particolarmente interessato, sapevo che la mia occasione era la prova in linea. A cinque chilometri dalla partenza, in discesa, sono caduto. Erano tutti ancora più convinti che avessi sprecato dei soldi. Avevamo un giorno di pausa e quello dopo la gara che stavo aspettando: quando ho tagliato il traguardo per primo, non potevo crederci; perfino il mio coach non riusciva a dire nulla. Quest’anno, dopo cinque anni, sono riuscito nuovamente a riprendermi quel titolo, speravo che mi avrebbe aiutato a rinnovare il mio contratto con il mio team qui in Europa.
Secondo te cos’è che non vediamo e non capiamo noi spettatori di cosa significhi essere un ciclista oggi?
Senza un agente è veramente difficile trovare una squadra. Ho lavorato per il mio team in ogni gara a cui ho preso parte: non ho lottato per me stesso o per un risultato, non mi è mai stata data la possibilità di mostrare cosa le mie gambe potessero fare perché ad ogni competizione il mio compito era quello di supportare il team. Ero felice di farlo, ma quando ora le squadre mi chiedono dove siano i miei risultati, non ho prove tangibili da dargli riguardo il mio valore e le mie capacità da ciclista. Mi sarebbe bastata anche solo un’opportunità. Qualcuno ha provato a tirarmi su il morale dicendomi che se non dovessi trovare una squadra, potrei sempre cercare un nuovo lavoro in Europa. Ma non ho bisogno di nessun lavoro, voglio solo continuare a lottare per il mio sogno, essere un ciclista professionista, per salvare la mia vita e la mia famiglia. Per giunta non è così facile per me trovare un altro lavoro come può esserlo per chi è europeo, basti pensare alla fatica con cui riuscirei ad ottenere un visto.
Se potessi continuare a pedalare, a quale gara ti piacerebbe partecipare?
In queste due stagioni ho imparato moltissimo e vorrei applicarlo. Vorrei mostrare agli altri cosa riescono a fare le mie gambe in salita, vorrei che le persone cominciassero a conoscermi, a vedermi. Mi piacerebbe poterlo fare al Tour de France.
Riesci ad immaginare un futuro senza ciclismo?
Sarebbe veramente difficile vivere una vita senza ciclismo.
Sono passate alcune settimane dalle parole che state leggendo. In questo momento Negasi è a casa in Tigray, assieme alla sua famiglia. Alla fine dell’anno, non avendo al momento una squadra, il suo visto scadrà e verrà espulso dall’Italia. Lui continua a sognare, sperando che quel messaggio lasciato in una bottiglia virtuale, alla quale spero di dare una spinta nella giusta direzione, raggiunga le rive di una nuova squadra che lo possa accogliere.
Foto: Sprint Cycling Agency
Ho visto ciclisti incontrare il mondo dall'alto
Allo scrittore Thomas Bernhard sono serviti cinque volumi per raccontare la sua vita, in maniera tanto scomposta che solo nell’ultimo ha affrontato la sua infanzia. O per lo meno quelli che erano i suoi primi ricordi fino ad arrivare all’ingresso nel collegio di Salisburgo. Proprio all’inizio di “Un bambino” racconta che, all’età di otto anni, senza chiedere il permesso a nessuno, aveva deciso di portare fuori dall’androne la bicicletta militare del tutore, allora sotto le armi in Polonia, salire in sella, provare a spingere sui pedali e scoprire cosa sarebbe accaduto. Seppure le dimensioni della bicicletta fossero decisamente sproporzionate per un bambino della sua età, si sentiva “un trionfatore” nell’esplorare prima il Mercato dei piccioni di Traunstein e poi allontanarsi dalla cittadina per provare a raggiungere la zia Fanny a Salisburgo. Chiudendo gli occhi sui rettilinei per assaporare quella felicità, Bernhard capì che “è dunque così che il ciclista incontra il mondo: dall'alto! Corre, corre a folle velocità senza toccare terra con i piedi, essere un ciclista è per lui qualcosa che significa quasi: sono il padrone del mondo”.
Io, che per ora in sella ad una bici vado a zigzag e cerco di tenermi lontana da muri, pali e pilastri, ne so poco di sentirmi in cima a tutto, ma ho pensato fosse una buona idea essere nel luogo in cui i migliori ciclisti si sono dati appuntamento per correre velocissimi senza toccare terra con i piedi e alcuni, addirittura, provare a sentirsi padroni del mondo. Venerdì sarebbe dovuto essere come il primo giorno delle vacanze di Natale: volevo tornare ad avere otto anni come Bernhard e provare sulla salita di Witikon la curiosità e l’entusiasmo di chi non vede l’ora di scoprire cosa si nasconde sotto l’albero addobbato in salotto. Chissà se anche per Muriel Furrer il giorno precedente, quello della gara in linea junior, assomigliava ad un giorno di festa, se quella mattina si è sentita trionfante come quando da bambina è riuscita a pedalare per la prima volta, chissà cos’è successo sotto la pioggia scrosciante nei pressi di Küsnacht mentre scendendo affrontava una leggera curva a sinistra, chissà perché si debba morire a 18 anni da soli, senza che nessuno se ne accorga per almeno un’ora e mezza, facendo la cosa che si ama di più al mondo. Quel venerdì, la mia prima volta ad un Mondiale di ciclismo, nella fan zone di Witikon lo schermo che trasmetteva la gara non emetteva altro che rumori ambientali, mentre tifosi belgi e qualche altro spettatore sul bordo della strada provava a far finta che quella degli uomini U23 fosse una gara normale, ancora una volta sotto la pioggia.
Pioveva anche il giorno successivo ad Uster, alla partenza della gara in linea femminile. Faceva freddo fuori e dentro nel guardare le atlete della federazione ciclistica svizzera disporsi davanti al peloton e mischiare lacrime e pioggia nel minuto di silenzio per ricordare una ragazza che un giorno sarebbe voluta essere in mezzo a quel mucchio di caschi, ruote, gambe che fremono. In quello che era ufficialmente diventato il mio campo base, ovvero la salita di Witikon, ho scoperto che rumore fanno le ruote quando passano sul bagnato a tutta velocità, ho visto un centinaio di cicliste affrontare condizioni proibitive regalando a tutti uno spettacolo sportivo pari a quello di tante gare maschili. Mentre la giacca antipioggia mi abbandonava e urlavo forte il suo nome, a pochi metri da me, Elisa Longo Borghini si è alzata sui pedali per non perdere nemmeno un centimetro dalle ruote di chi aveva davanti. Qualche minuto dopo, sotto un gazebo zuppo come noi esseri umani, circondata da belgi che intonavano a ritmo “Lotte”, ho sperato che tutto potesse succedere ma ho sorriso comunque per quel bronzo che ci ricorda che abbiamo una delle atlete più forti al mondo, anche se non lo diciamo spesso. Prima di sabato, tra i ciclisti italiani, potevano vantare almeno tre podi al Mondiale Paolo Bettini, Gianni Bugno, Beppe Saronni, Francesco Moser, Felice Gimondi, Alfredo Binda, Tatiana Guderzo, Giorgia Bronzini, Maria Canins, Morena Tartagni, a loro si è aggiunta anche Elisa Longo Borghini.
La verità è che prima che la tragedia piombasse su uno degli eventi più importanti dell’anno era la giornata di domenica che portava con sé una sfida diversa dalle altre: c’era solo da capire se sarebbe stata la ciliegina sulla torta di un’estate rasente la perfezione per Remco Evenepoel che dopo i due ori olimpici, sicuramente aveva fatto un pensierino anche su quelli Mondiali, o se, invece, sarebbe stata un’altra Storia, con la S maiuscola, che parlava un po’ italiano, un po’ francese, ma soprattutto sloveno. Che fosse la giornata per eccellenza lo si capiva già dalla partenza a Winterthur, quando è comparso per la prima volta il sole: durante questi Mondiali il meteo ne ha sempre saputo qualcosa più di noi comuni mortali. Ancora una volta sulla salita di Witikon, questa volta l’ambiente che mi circondava aveva un aspetto completamente diverso. Lungo la pendenza fino al 10 per cento, i volti si erano moltiplicati rispetto ai giorni precedenti. C’è chi aveva portato le casse per animare l’attesa con musica internazionale (non sono mancati nemmeno Nek ed Eros Ramazzotti, per la cronaca), chi proponeva su un cartello un nuovo ordine mondiale con a capo Tadej Maočar, Joseph Rogline, Mathieu Trump der Poel e Remco Jong Un, chi, già affamato, aveva con sé tutto il necessario per una bella grigliata con annessa bevuta, chi speranzoso preparava i fumogeni e chi con le bombolette spray o i gessetti scriveva sull’asfalto per ricordare non solo Muriel, ma anche Gino.
Sembrava un’orda quella che è salita la prima volta, poco dietro la fuga, poi piano piano il gruppo ha cominciato a spezzettarsi come fa sempre quando la gara entra nel vivo. Eravamo a dir poco stupiti quando, a poco meno di 100 chilometri dall’arrivo, abbiamo visto una maglia verde davanti a tutti avvicinarsi sempre di più e poi sfrecciare accanto a noi. Abbiamo contato, chi con le dita, chi a mente, chi con le app del telefono, i secondi prima di vedere comparire Remco Evenepoel e Mathieu van der Poel. Abbiamo visto prima il ghigno di dolore di Bagioli nel vano tentativo di stargli a ruota, poi di Pavel Sivakov. Il fatto che il distacco, delle volte, fosse meno di un minuto dagli altri grandi avversari ha lasciato per un attimo uno spiraglio aperto su possibili scenari che non abbiamo visto accadere, perché, come era successo a settembre alle Strade Bianche, quel giorno Pogačar aveva deciso di trasformarsi nell’Hulk di cui ha spesso un adesivo sul manubrio. L’ultima volta sul Witikon davanti c’era solo lui, da solo, una frazione di secondo e un attimo dopo era il padrone del mondo. Adesso possiamo dire che dopo Eddy Merckx e Stephen Roche, anche Tadej Pogačar è riuscito a vincere Giro, Tour e Mondiale nello stesso anno. Per molti l’irresistibile sloveno ha la stoffa per sorpassare il primo, ma per quanto Merckx, il Cannibale, all’Équipe ha ammesso, poco dopo la gara, che a Zurigo è riuscito a fare qualcosa di speciale, il grande corridore belga continua comunque ad essere convinto che il ragazzo ne debba mangiare di avversari ed asfalto per raggiungerlo.
Mentre risalgo la strada che è stata casa per due giorni e mezzo, so che devo darmi tempo e che probabilmente la mia faccia assomiglia a quella di Pogačar, che ai microfoni, dopo la gara, non faceva che ripetere che, durante la corsa, non aveva la minima idea di cosa stava facendo. Qualcuno metabolizza descrivendo a voce alta i passaggi più belli dei sette a cui abbiamo assistito, qualcuno prova a fare un’esamina della nostra Nazionale, qualcuno apre ogni piattaforma social per poter condividere incredulità, entusiasmo, felicità. Speravo che ogni giorno sarebbe assomigliato a Natale e alla fine è arrivato. Non ho comunque la minima idea di cosa io abbia visto: forse un sogno, forse un’impresa, forse ho solo visto un uomo incontrare dall’alto il mondo e rimanere lì, almeno per un po’. Sicuramente ho visto il ciclismo, quello che toglie, quello che dà. Mentre riordino i ricordi, immagino un futuro in cui sull’asfalto non si dovrà ricordare ma solo pedalare veloci, senza toccare mai terra.
Foto: Sprint Cycling Agency
Benvenuta Cima Alfonsina Strada
Lungo la strada asfaltata che porta al Rifugio Pomilio, nonostante la luce accecante di un sole di metà luglio che non sembra avere pietà per gli esseri umani, è impossibile non notare un segnale stradale diverso dal solito. Doveva essere un semplice stop, invece lo street artist toscano Dela Vega, il cui vero nome è Matteo Filippeschi, ha aggiunto un rosa “don’t” e sotto ha disegnato una ragazza in bicicletta. Non è casuale nemmeno lei, soprattutto non quest’anno, non qui in cima al Blockhaus. Lo dicono lo sguardo sfidante, i capelli corti neri e la scritta sulla maglia che quella non è una ciclista qualsiasi, ma Alfonsina Strada.
Cento anni fa, con grande riluttanza del mondo ciclistico e dopo aver corso già due Giri di Lombardia, Alfonsa Rosa Maria Morini, da coniugata Strada, si iscrisse al Giro d’Italia. Qualcuno sostiene che Emilio Colombo e Armando Cougnet, direttore uno e amministratore l’altro della Gazzetta dello Sport, avessero ceduto solo perché i grandi nomi, come Girardengo e Bottecchia, avevano deciso di non prendere parte alla corsa rosa se non fossero state garantite loro ricompense in denaro. La risposta dall’alto fu un secco no e così Alfonsina divenne per qualcuno un elemento promozionale, per altri la ragione per cui il Giro d’Italia si prospettava una pagliacciata. Non le importava molto, né del fatto che il suo nome, a pochi giorni dalla partenza, non compariva nella lista dei partecipanti, né che la Gazzetta dello Sport si perse una “a” riportandola come “Alfonsin Strada di Milano” e che il Resto del Carlino le andò dietro rinominandola “Alfonsino Strada”. Partì come tutti gli altri, con il numero 72 cucito sulla divisa nera, pronta a percorrere 3.613 chilometri. È stata dedicata a lei la cima della settima tappa del Giro d’Italia Women, quella regina, quella di un Blockhaus su cui il peloton femminile non era ancora mai salito: se gli uomini hanno da moltissimo tempo una Cima Coppi, da quest’anno le donne hanno una Cima Alfonsina Strada.
A Lanciano, in partenza, le ragazze sono state accolte da un caldo afoso che ha tenuto loro compagnia dall’inizio della gara, ma anche dall’affetto della gente del posto: l’atmosfera assomigliava a quella fatta di fiori e striscioni che attendeva sempre Alfonsina alla fine di ogni tappa. Il percorso, a guardare l’altimetria, si capiva che, fin dall’inizio, di tempo per rifiatare non ne avrebbe dato molto: le strade in pendenza verso Guardiagrele, Bocca di Valle, Pretoro e La Forchetta erano solo l’antipasto di una doppia ascesa a Passo Lanciano e poi l’arrivo in cima al Blockhaus. Duro è l’unico aggettivo che è venuto in mente a Mavi García per definire ciò che le aspettava: non credeva ci sarebbe stato spazio per pensare a strategie, sarebbe stata una lotta di resistenza, le gambe avrebbero deciso chi avrebbe avuto la meglio. Sarebbe potuta essere una tappa per lei, per scalatrici pure come lo sono anche Juliette Labous e Niamh Fisher-Black, ma la verità è che tutti gli occhi erano puntati su due cicliste in particolare: la maglia iridata della SD Worx, Lotte Kopecky, e la maglia rosa della Lidl-Trek, Elisa Longo Borghini, avevano solo 3 secondi di distacco nella classifica generale. La domanda che si rincorreva fin dal mattino era se la tappa regina sarebbe stata anche quella della resa dei conti o se, invece, sarebbe stata rimandata al giorno successivo, che non si prospettava decisamente più gentile.
Nei primi chilometri, si sono alternati tentativi coraggiosi di attacchi e ritiri, come quello di Martina Alzini e delle sorelle Giada e Letizia Borghesi, le prime di una lunga lista. Solo Claire Steels, 37 anni e al suo primo Giro d’Italia Women, è riuscita a prendere abbastanza distanza dal gruppo per non esserne risucchiata di nuovo al suo interno. È stata, però, solo questione di tempo, perché all’attacco della prima salita verso Passo Lanciano, il peloton si è ricompattato con facilità. La pendenza all’8,6% ha fatto la sua scrematura, risparmiando la belga Justine Ghekiere, che si è aggiudicata il gran premio della montagna e, complice il ritiro di Clara Emond, anche la maglia azzurra da miglior scalatrice alla fine della giornata. Quando è arrivato l’attacco del Blockhaus, a valle c’erano 35 gradi ed è stata Gaia Realini, nata a non molti chilometri da lì e conoscitrice a menadito di quelle strade, a tirare il gruppo per la sua capitana e a mietere vittime, anche di un certo calibro, con il suo ritmo. Ha provato addirittura a fare la differenza ad un certo punto, accelerando ulteriormente, ma è stata Neve Bradbury a sorprendere il gruppo con un attacco deciso. La giovane australiana è riuscita a creare un gap interessante, mentre dietro la maglia rosa e quella iridata si studiavano. Almeno è stato così fino a sette chilometri dall’arrivo quando Elisa Longo Borghini ha provato a staccare la campionessa belga, che non aveva alcuna intenzione di mollare la sua ruota. Ha tentato una, due, anche tre volte, ma l’altra sembrava fosse un magnete. Arrivati all’ultimo chilometro, era chiaro che sarebbe stata la giovane ventiduenne della Canyon-SRAM a vincere la tappa regina di questo Giro d’Italia Women e che dietro ci si preparava ad una volata: Kopecky è partita a pochi metri dal traguardo, Longo Borghini ha cercato di eguagliare la sua esplosività ma la belga è riuscita a spuntarla, arrivando davanti. Seconda e terza, il distacco era diventato di un solo secondo. Il giorno dopo è una pagina del nostro ciclismo che aspettavamo di scrivere da 15 anni.
Il resto del peloton è arrivato frammentato con distacchi altissimi: qualcuna aveva mollato la presa e si è goduta la salita, qualcun’altra aveva il viso rigato dalle lacrime per via della fatica e del caldo. Si sono incrociate lungo la strada quelle che scendevano verso i pullman e quelle che, invece, erano ancora alle prese con gli ultimi chilometri. Chi non aveva ceduto alle lacrime in salita, si è lasciata andare in discesa: Gaia Realini è stata una di loro, ha chiesto scusa a Paolo Dalla Costa, direttore sportivo di Eletta Trentino cycling Academy, che era proprio all’attacco dell’ultimo chilometro lungo la strada, avrebbe voluto fare di più, magari anche vincere davanti alla gente di casa sua. Paolo le ha tenuto il viso tra le mani, le ha asciugato le lacrime, ma soprattutto l'ha fatta ragionare, l’ha riportata a sé, a quello che ancora non realizzava di aver fatto e che era stato fondamentale per la sua squadra. Io ero seduta sull’asfalto proprio accanto a Paolo, che mi aiutava a riconoscere le atlete, mi raccontava le loro storie, mentre le incitavamo una ad una. Altre si sono fermate per un saluto, un abbraccio. Mi chiedo ancora adesso perché mi abbia così sorpresa un gesto così semplice e umano. Forse lo sport mi aveva preparato ad altro. Il caldo, per fortuna, mi ha distratto dal nodo in gola che avevo accumulato nel vederle arrivare, nonostante tutto, alla meta.
Durante l’ottava tappa del Giro d’Italia del 1924, Alfonsina Strada arrivò fuori tempo massimo, ma non fu esclusa dalla gara: si applicò la stessa decisione presa qualche giorno prima per Aperlo e Cividini, dunque le fu permesso di continuare a pedalare ma i suoi tempi non sarebbero stati conteggiati ai fini della classifica. Da Milano partirono in novanta e solo trenta arrivarono in fondo, tra loro c’era anche Alfonsina. Non aveva fatto un passo indietro nemmeno nell’infinita tappa tra Bologna e Fiume, che la tenne in sella per 21 ore. Al termine della corsa rosa, in un’intervista al Guerin Sportivo disse: “Sono una donna, è vero. E può darsi che non sia molto estetica e graziosa una donna che corre in bicicletta. Vede come sono ridotta? Non sono mai stata bella; ora sono... un mostro. [...] Ho le gambe buone, i pubblici di tutta Italia (specie le donne e le madri) mi trattano con entusiasmo. Non sono pentita. Ho avuto delle amarezze, qualcuno mi ha schernita; ma io sono soddisfatta e so di avere fatto bene.”
Al termine di un’altra tappa di un altro Giro, quello a noi contemporaneo, è abbastanza evidente che abbiano fatto bene e possano essere soddisfatte, per usare le parole di Alfonsina, tutte le 106 cicliste che sono riuscite ad arrivare in vetta alla cima a lei dedicata. Anche quelle che sono partite da Lanciano, ma che non sono riuscite a compiere la stessa impresa. Tutte hanno pedalato al meglio delle loro capacità, hanno sofferto finché sono riuscite a soffrire e forse anche oltre, sono riuscite a trasformare la fatica in quella bellezza che Alfonsina non trovava più in sé stessa dopo la corsa rosa. Perché le donne che corrono in bicicletta sono bellissime: vanno veloci, salgono in alto, spingono con tutta la forza che hanno sui pedali, emozionano loro stesse e anche chi si trova lungo un percorso di gara a guardarle, lo fanno come chiunque abbia mai provato le due ruote e se ne sia perdutamente innamorato.
Foto: Sprint Cycling Agency
Una ciclista versatile e combattiva: intervista a Kasia Niewiadoma
A detta di Wikipedia, Ochotnica Górna è un villaggio situato a sud della Polonia che non conta più di 2.100 abitanti ed è particolarmente frequentato da chi ama le attività outdoor, meglio ancora se invernali, vista la vicinanza con i monti Gorce. Le immagini sul sito istituzionale confermano che si tratti proprio di un piccolo paradiso naturale su Terra con una grande storia di resistenza durante la seconda guerra mondiale. Già da queste poche informazioni non dovrebbe sorprendere che sia nata proprio qui, il 29 settembre 1994, una delle migliori scalatrici del ciclismo femminile contemporaneo, Katarzyna “Kasia” Niewiadoma.
Cresciuta nel club WLKS Krakus BBC Czaja e allenata da Zbigniew Klek, che precedentemente aveva scoperto e allenato anche Rafał Majka, nel 2013 il mondo ciclistico comincia ad incuriosirsi a questa ragazza di 18 anni dal sorriso gentile che se la cava piuttosto bene nelle fila della TKK Pacific Torun. Supportata anche da Paulina Brzezna-Bentkowska e dal marito Pawel, Kasia arriva quinta ai Campionati Europei under 23 di quell’anno, piazza che le vale una proposta dell’allora Rabo-Liv di unirsi a loro come stagista per il resto della stagione e che sarà solo l’antipasto dei titoli ottenuti a Tartu nel 2015 e a Plumelec nel 2016. Durante l’Holland Ladies Tour vince la classifica delle giovani e ottiene ufficialmente il suo posto in squadra. Nel 2014 arrivano la sua prima vittoria UCI, al Frauen Grand Prix Gippingen in Svizzera, il terzo posto a cronometro ai campionati nazionali polacchi e il suo primo Giro d’Italia, concluso all’undicesimo posto dopo aver aiutato a portare sul podio tre compagne di squadra, tra cui una certa Marianne Vos proprio sul gradino più alto. Chissà se è stato, invece, nel 2015 che è cominciato a nascere l’amore tra Kasia e le classiche primaverili: quell’anno si piazza sesta alle Strade Bianche e quinta alla Freccia Vallone; quello successivo si migliora, arrivando seconda dietro alla campionessa del mondo Elizabeth Armistead alla classica toscana e quarta a quella belga; mentre nel 2017 è ancora seconda alle spalle, questa volta, di Elisa Longo Borghini a Siena e terza in tutte e tre le classiche delle Ardenne. Di sicuro continua il feeling nato con il Giro d’Italia dove vince la maglia bianca di miglior giovane, ripetendosi anche nel 2016, l’anno delle sue prime Olimpiadi a Rio de Janeiro (sesta nella prova in linea) e del suo primo podio ai Campionati Europei tra le grandi (terza nella prova in linea). All’OVO Energy Women’s Tour del 2017 arriva finalmente il gradino più alto del podio nel World Tour, non solo conquistando la prima tappa, ma anche la classifica generale. L’anno seguente comincia la stagione indossando una nuova maglia, quella della Canyon-SRAM, la stessa che ha addosso ancora oggi: dopo un altro secondo posto alle Strade Bianche, si prende in solitaria la 43esima edizione del Trofeo Alfredo Binda a Cittiglio, attaccando sul suo terreno preferito, la salita.
Nel 2019 il gradino più alto del podio arriva nella quarta tappa dell’OVO Energy Women’s Tour di quell’anno: è un giovedì pomeriggio a Burston Dassett, il 13 giugno per la precisione, e in volata supera Liane Lippert e Lizzie Deignan, sotto un cielo umido e grigio. Quel giorno Kasia è il sole che manca alla giornata, ma non sa che ci vorranno cinque anni prima di ritrovare la vittoria in una gara World Tour. Si instaura un pattern di secondi, terzi o quarti posti che si ripete negli anni come un disco rotto. C’è chi analizza il suo modo di correre, crede che la motivazione delle vittorie sfiorate sia tutta nell’eccessiva aggressività con cui si approccia alla gara. Ma forse il problema è pensare che nello sport conti solo la vittoria: Kasia infatti nel 2020 conquista un bronzo nella prova in linea dei Campionati Europei a Plouay e il secondo posto in classifica generale al Giro d’Italia, mentre nel 2021 è la volta di un altro bronzo, questa volta mondiale, nelle Fiandre. Continua a correre come la ciclista versatile che è sempre stata, perfettamente a suo agio e tra le favorite sia nelle gare di un giorno, che nei Grandi Giri. È difficile non credere che si tratti solo di una ragazza in sella ad una bicicletta che prova ad inseguire un sogno, un gradino del podio più alto di quello precedente. Per sé stessa, non per noi.
Questo, ovviamente, non la rende immune dalla frustrazione dello sfiorare spesso il raggiungimento dei propri obiettivi: tagliato il traguardo, sfinita, spesso si appoggia al manubrio con il viso contratto, rigato dalle lacrime. Torna a casa a Girona, cercando spesso conforto nei consigli del marito, Taylor Phinney, ex ciclista professionista prima per la BMC Racing Team, poi per l’EF Education First, che non ha smesso nemmeno per un secondo di essere il suo primo fan. Si sono conosciuti durante i Campionati Mondali in Qatar nel 2016 ad un buffet di colazione: Kasia sostiene che sia stato tutto merito delle sneakers che aveva ai piedi e che hanno attirato l’attenzione di lui.

Ma a furia di andare a tentoni nel buio si trova sempre uno spiraglio di luce: nella scorsa edizione del Tour de France femminile non vince nessuna tappa, ma alla fine è lei la regina della montagna e la maglia a pois si intona benissimo con il sorriso che sfoggia a Pau. Qualche mese dopo, alla seconda edizione dei Campionati Mondiali Gravel in Veneto, squarcia definitivamente quel buio, battendo Silvia Persico e Demi Vollering. Un’altra maglia, questa volta iridata, che Kasia dice vada indossata esclusivamente con pantaloncini neri. Non è la sua specialità, lei appartiene alla strada, ma è un’iniezione di fiducia per la stagione di quest’anno. Quando arriva quarta alle Strade Bianche e seconda al Giro delle Fiandre, in tanti temono che non ci sia fine al lunghissimo tunnel in cui l’hanno vista entrare un giorno del 2019 e da cui è uscita solo per brevi intermezzi. Ma al 31esimo tentativo, la Freccia Vallone, ancora una volta in una giornata piovosa, lancia la sua zampata, staccando sul Mur de Huy le favorite della giornata, Elisa Longo Borghini e Demi Vollering. Tagliato il traguardo, Kasia piange di nuovo, questa volta però di gioia. Perché qualsiasi cosa fosse quel limbo, è finalmente finito. Ai microfoni, dopo la gara, dice che spera di aver ispirato chi sta inseguendo i propri sogni da molto tempo a non mollare, che lei ne sa qualcosa di fallimenti ma non ha mai smesso di credere che il suo team fosse in grado di vincere una gara e la ricompensa è bellissima.
Mi sono commossa anche io quel 17 aprile. Senza rendermene conto ero finita piuttosto vicina allo schermo del televisore quando lei, Longo Borghini e Vollering sono arrivate all’attacco del Mur de Huy. Quando l’ho vista staccarle, ho capito perché questo sport riesce a insegnarti moltissimo anche solo guardandolo. Stavo assistendo ad una masterclass di tenacia ed ero lì che prendevo appunti. Li ho presi anche qualche pomeriggio fa, mentre tenevo il telefono in mano e dall’altra parte della cornetta c’era lei, da qualche parte sull’Alpe d’Huez in ricognizione per il prossimo Tour de France.
Comincio facendoti una domanda sulla tua terra, la Polonia. Una volta hai descritto le persone che vengono dalla tua regione come emotive, ma allo stesso tempo piuttosto combattive. Quanto ti influenza come ciclista questa tua origine?
Credo che abbia una grandissima influenza su di me, perché ho vissuto per quasi 20 anni in quei luoghi. Ovviamente da bambina le persone che mi circondavano hanno contribuito alla mia crescita, anche come ciclista: erano tutti molto grintosi, competitivi e hanno sempre lottato per quello che volevano ottenere.
Ti ricordi la prima volta che sei salita in sella ad una bicicletta?
Ricordo bene le prime esperienze in bicicletta, anche se inizialmente non avevo una bici da strada. Sono cresciuta circondata da molti bambini, soprattutto cugini, e passavamo parecchio tempo a pedalare. La prima che abbia mai avuto era una vecchia bicicletta di mio fratello. C’era libertà, ma anche competizione: ci divertivamo a sfidarci sulle salite per vedere chi sarebbe stato più veloce ad arrivare in cima, mentre in discesa cercavamo di usare i freni il meno possibile. Ogni volta ci inventavamo un gioco diverso, che richiedeva sempre di essere in sella ad una bici.
Una persona una volta mi ha detto che il ciclismo è uno sport creativo, sei d’accordo?
Assolutamente sì, ma il ciclismo e l’andare in bicicletta sono due cose differenti. Solitamente quando parliamo di “ciclismo” la prima cosa a cui pensiamo è il mondo competitivo delle gare. Mentre andare in bicicletta significa andare nei luoghi, passare del tempo con i tuoi amici, esplorare nuove strade e non avere paura di fermarti più volte per guardarti intorno. Il ciclismo è molto più definito dagli allenamenti, avere dei programmi da seguire, attenersi a dei numeri. Cerco di combinare entrambi i mondi nella mia vita: ci sono volte in cui sono molto più concentrata sulla mia tabella di marcia, altre in cui mi piace andare a fare un giro in bicicletta con mio marito e i miei amici, senza pensare a quanto veloce o forte sto andando, ma solo a quanto libera mi sento in quel momento, a tornare in qualche modo a come mi sentivo quando ero bambina.

Sei sempre stata molto aperta riguardo ciò che provi. Che rapporto hai oggi con le tue emozioni e quanto è importante per te avere nella tua vita qualcuno come Taylor che non è più parte del mondo World Tour?
È sicuramente di grande supporto, perché lui è stato nei miei panni, ha sperimentato quello che sto sperimentando, ma allo stesso tempo ora lo sperimenta da un punto di vista diverso. Delle volte sono tornata a casa da una gara portando con me moltissime emozioni, dalla delusione alla felicità, dalla rabbia al sollievo, ed è difficile riuscire a metabolizzare tutto questo da sola. Ma quando hai una persona con cui puoi parlare apertamente e condividere con lui o lei qualsiasi cosa tu stia provando, o che ti fa le domande giuste, è molto più facile andare oltre e imparare qualcosa dall’esperienza che hai appena vissuto. Sono molto fortunata ad avere Taylor nella mia vita, perché lui è piuttosto aperto riguardo le sue sensazioni ed emozioni e non ha paura di ammettere che non è sempre tutto bellissimo in sella alla bici, ma ci sono altre sfumature di cui spesso non si parla.
Anche tu non hai mai nascosto le difficoltà di questi anni in cui la vittoria, che sembra essere l’unica cosa che conta per il mondo sportivo, non arrivava. Come sei riuscita a non trasformarla in un’ossessione?
Ad essere sincera, anche se non ho vinto per molto tempo, ogni anno c’era sempre qualcosa di nuovo che accadeva: una medaglia ai Mondiali per la prima volta o la maglia a pois al Tour de France. Ci sono state molte prime volte che mi hanno motivato a non mollare, a continuare ad avere fede e ad essere paziente. Una delle cose più importanti che Taylor mi ha insegnato è proprio questa, a fidarmi dei tempi, a non affrettare le cose. Siamo due persone diverse: io sono più una testa calda, lui è più spensierato. Delle volte dimentico che le cose hanno bisogno di tempo ed è lui a ricordarmelo.

Comunque le vittorie sono arrivate: prima ai Campionati Mondiali Gravel e poi la Freccia Vallone. Quale delle due è stata più importante per te?
Sono due vittorie entrambe speciali a modo loro. Sicuramente indossare la maglia iridata, anche se non nella mia disciplina principale, mi ha dato molta motivazione e fiducia nel fatto che non era finita, che un giorno avrei potuto indossare la stessa maglia anche su strada. Quando non vinci per tanti anni, cominci a dubitare di te stessa un pochino, perciò quella vittoria è stata qualcosa di cui avevo decisamente bisogno per iniziare questa stagione con una mentalità diversa. Mi ha sicuramente aiutata nel vincere la Freccia Vallone: durante quei Mondiali ho battuto Demi Vollering e perciò ho potuto realizzare che non sarei stata per forza sempre dietro di lei.
Sei ad altissimi livelli da molto tempo, come fai a mantenere la motivazione e la passione per questo sport?
Una cosa che ho scoperto negli ultimi anni è che non posso essere concentrata solo sui risultati, ho bisogno di prendermi del tempo per me, per le persone che amo. Quando parlo di “tempo per me stessa”, non parlo di tempo senza fare nulla o che non riguardi la bici, anzi. Semplicemente pedalo a velocità e su bici diverse. Ci sono stati anni in cui sono stata tutto il tempo in sella ad una bici da strada e ad un certo punto finivo per sentirmi mentalmente stanca nel tentare di rincorrere sempre gli stessi obiettivi. Ora, invece, dopo una gara mi piace prendermi due o tre giorni per divertirmi in bici, con Taylor e con i nostri amici. Usciamo di casa la mattina e torniamo spesso che è quasi sera. Quei giorni mi permettono di mantenere la passione per il ciclismo, è grazie a quei giorni che posso tornare a concentrarmi durante gli allenamenti, perché in quel modo la bicicletta continua ad essere qualcosa che mi dà grande gioia.
Il ciclismo femminile sembra un mondo ancora tutto da esplorare, basti pensare che quest’anno il Tour de France compie solo il suo terzo anno. Pensi che ci siano luoghi di questo mondo che abbiano bisogno di più luce?
È interessante quello che è successo con il Tour de France, perché si tratta di un gara iconica e già dalla prima edizione è diventata una cosa importante, che ha permesso al ciclismo femminile di crescere. Ogni anno si notano grandi differenze nel nostro mondo, che si tratti di nuove gare da correre o di giovani cicliste che spuntano o diventano più forti. Abbiamo un calendario piuttosto pieno e forse delle volte il tempismo non è dei migliori per dare visibilità a tutte le gare: se per esempio la Vuelta femminile fosse più vicina a quella maschile, magari potrebbe attirare più attenzione e visibilità, anche perchè dopo le classiche siamo tutti alla ricerca di una pausa dal ciclismo.
A proposito di gare che, invece, non sono nel vostro calendario, ti piacerebbe un giorno prendere parte alla Milano-Sanremo?
Assolutamente sì! Quando viene rilasciato il calendario della nuova stagione, ogni anno spero sempre che compaia anche nel nostro. Mi piacerebbe che ci fosse anche il Giro di Lombardia.
C’è qualcosa che ti piacerebbe lasciare dietro di te nel ciclismo femminile?
Mi piacerebbe un giorno lasciare questo mondo sapendo che ho aiutato giovani cicliste a trovare la loro strada. Credo che cicliste come Elisa Longo Borghini o Demi Vollering siano un ottimo esempio di come si possa essere atlete fortissime, vincere gare ciclistiche, allenarsi nel modo giusto ma allo stesso tempo farlo senza ossessionarsi o cadere negli estremi. Spero che per alcune giovani cicliste io possa essere un esempio come loro*. Alla fine dei conti, la cosa più importante è cercare di rendere questo sport un posto migliore senza fare cose folli o poco sane.

*Mentre scrivevo quest’intervista, c’è stata la terza tappa del Tour de Suisse femminile, quella che andava da Vevey a Champagne: Kasia e la giovane compagna di squadra Neve Bradbury sono state in fuga per 91 chilometri, hanno pedalato l’una accanto all’altra quando il traguardo era oramai vicino. A pochi metri dalla linea bianca sull’asfalto, Kasia le ha messo una mano sulla schiena, ha rallentato quanto bastava perché Neve potesse essere la prima a superare quella linea e godersi la sua prima vittoria da professionista. Un passo dietro di lei, ma con le braccia alzate nella stessa posizione e la stessa gioia sul viso, che si è poi trasformata in abbracci e infiniti baci. Sono certa che Neve, dopo quella tappa, non avrà dubbi, come noi, sul fatto che Kasia sia uno dei migliori esempi in circolazione nel ciclismo femminile.
Il ritorno dell'(ex) cittì: intervista a Davide Cassani
Si sono emozionati in tanti quando è uscita la notizia che sarebbe tornato alla telecronaca non solo per il Giro d’Italia, ma anche per il Tour de France e i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ho provato lo stesso anche io, che la sua voce l’ho scoperta solo recentemente da video di altre gare, altri tempi, su consiglio di amici. Mi dispiace non aver vissuto i suoi anni a fianco di Auro Bulbarelli, le ricognizioni delle tappe del Giro d’Italia e delle salite più famose. Dopo 28 anni dal Giro di Sardegna, la sua prima gara commentata a fianco di Adriano de Zan, dopo poco più di 10 da quel giorno in cui, a casa di Alfredo Martini, gli fu offerto il posto da ct della Nazionale maschile su strada, ho finalmente modo di recuperare il tempo perso: Davide Cassani è pronto infatti ad indossare di nuovo le cuffie e a prestare la sua voce al ciclismo.
Ho pensato che non potesse esserci Virgilio migliore per continuare il mio viaggio all’interno di questo folle mondo su due ruote. Per questo, in punta di piedi, un caldo pomeriggio primaverile gli ho rubato del tempo che presto sarà occupato da chilometri e chilometri di fughe, salite, piccole e grandi imprese. Volevo riflettere con lui sui miei e i suoi nuovi inizi, sull’amore per questo sport, sul ciclismo che vorrebbe raccontare, sull’importanza del passato, sulle sembianze di questo presente e su quelle che avrà il futuro.
Sono passati più di 10 anni dalla sua ultima telecronaca, anche se nel frattempo non ha mai abbandonato del tutto il piccolo schermo ciclistico con le partecipazioni al “Processo alla tappa” o il Giro d’Italia in bicicletta elettrica. Come si sente per questo ritorno?
Mi sembra ieri quando ho fatto la mia ultima telecronaca nel 2013 al Giro di Lombardia. Invece sono passati 11 anni, sono tanti. Nel mezzo ci sono stati anche gli 8 da commissario tecnico. Cerco di capire se tutto questo è stato reale, se non è invece stato un sogno. Ma sembra decisamente tutto vero. Sono ben contento di tornare in telecronaca: sono sicuramente più maturo, non so se riuscirò ancora a fare bene questo lavoro (ride), però l’entusiasmo è quello di sempre.
C’è qualcosa che le è mancato della telecronaca in questi anni?
Sinceramente no. Anzi, devo dire che è un distacco che mi ha fatto bene, perchè dopo 18 anni sentivo il desiderio di fare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Quando ascoltavo le telecronache di altri, non provavo nessun risentimento, ero contento di ascoltarle e di non farle. Quando però mi hanno chiesto di tornare qualche settimana fa, mi sono sentito dentro la voglia di dire sì, perché mi è sempre piaciuto fare questo lavoro e torno a farlo con piacere.

Ad aspettarla c’è già il Giro d’Italia, a fianco di Francesco Pancani. Che Giro è pronto a raccontare e cosa ne pensa del percorso di quest’anno?
È un percorso come al solito impegnativo: ci sono due cronometro, c’è già un arrivo in salita al secondo giorno. Con la presenza di Pogacar, c’è un solo uomo da battere. Sarà uno contro tutti e non credo sarà affatto facile riuscire ad avere la meglio su di lui. Il percorso, comunque, è bello e se sarà appassionante o no, questo sarà tutto merito o colpa dei corridori.
C’è una tappa che la incuriosisce più di altre?
Sarò curioso di commentare la tappa di Prati di Tivo perché arriva dopo una settimana di gara, dopo una cronometro: sarà una tappa importante per capire tante cose.
Come ci si dovrebbe avvicinare, da neofiti, al ciclismo e coltivarne poi la passione anche da spettatori?
Con la curiosità di andare alla scoperta di qualcosa di nuovo. La bicicletta è tua: sei tu che ci pedali sopra, sei tu che decidi dove andare, con chi andare. È una bellissima scoperta, perché hai la possibilità di esplorare il mondo, però lo devi fare con l’accortezza giusta. È come quando si va a scuola: devi cominciare dalle elementari, l’università è lontana ma la puoi raggiungere. L’importante è cominciare con gradualità, non dare nulla per scontato. La bicicletta devi saperla guidare, ci sono delle insidie, dei pericoli. Quindi bisogna affrontare tutto con la massima attenzione e soprattutto cercando di dedicarsi ad una pedalata alla volta. Gli spettatori che, invece, guardano il Giro d’Italia non lo fanno solo perché hanno una passione per il ciclismo, ma soprattutto perché si rendono conto di vedere qualcosa di particolare. Il Giro non è una semplice corsa in bicicletta, fa parte della nostra Storia e della nostra cultura. Ci dà la possibilità di vedere tutto quello che circonda un gruppo di ciclisti. È importante poi andare a cercare di approfondire quello che si vede e che si sente, anche dai telecronisti: per uno spettatore curioso c’è l’occasione di imparare molte cose, sia tecniche che culturali.
Se lo ricorda il momento in cui si è innamorato del ciclismo?
Precisamente. Avevo 7 anni e mio padre mi portò a vedere un Campionato del Mondo vicino a casa mia. Rimasi così tanto affascinato da quella corsa che decisi che da grande avrei fatto il corridore e non ho più cambiato idea.

Le chiedo un altro ricordo: Alessandra Giardini nel documentario “Il cielo del Pirata” dice parlando di Marco Pantani: “Quello che noi cerchiamo in fondo, quando andiamo a vedere uno spettacolo, come è lo sport, è qualcuno che sia in grado di cambiarti la vita con un gesto“. C’è nella sua memoria ciclistica da corridore, commentatore e poi tecnico, un momento che assomiglia a qualcosa di simile?
Mi sono subito reso conto che il ciclismo era il mio sport, che la bicicletta sarebbe entrata prepotentemente nella mia vita, perché il primo giorno che sono salito in sella e sono arrivato sulle prime colline mi sono sentito come Cristoforo Colombo. La bicicletta mi ha dato la possibilità di scoprire il mondo, di sentire quello che provavo dentro. Questa sensazione è rimasta intatta nonostante siano passati più di 50 anni da quel giorno. È stato un amore a prima vista. Mi sono divertito moltissimo anche nella tappa del Tour de France in cui Marco Pantani è riuscito a conquistare la maglia gialla, scattando sul Galibier e riuscendo a sconfiggere un Jan Ullrich che sembrava imbattibile. Quella è stata veramente una bellissima telecronaca. Per giunta se penso a lui, a quel giorno, penso anche ad Adriano de Zan, che è stato il mio primo maestro. Fu emozionante.
Quanto è importante, secondo lei, per capire il ciclismo di oggi, conoscere e aver vissuto anche quello del passato?
Il passato, per quanto mi riguarda, è arrivato di conseguenza perché amavo così tanto quello che facevo che volevo sapere da dove arrivava. Allo stesso tempo, una persona che scopre la bici a 40, 50 o addirittura 60 anni non è importante che conosca il passato, è importante che capisca cosa la bicicletta o il ciclismo gli sta trasmettendo in quel momento.
Il ciclismo è bello anche per questo: c’è chi corre per vincere, chi corre per stare insieme ad altri, chi va in bicicletta per vedere luoghi, chi vuole conquistare una montagna senza guardare il tempo ma solo per arrivare in cima. Ognuno ha delle ambizioni, dei progetti, delle imprese da compiere e dunque trova la bellezza in quello che fa.
Ci sono due temi che ho visto particolarmente accesi in questo inizio di stagione, ma se sulla sicurezza si è già pronunciato sui suoi profili social e speriamo possano essere fatti dei passi avanti, mi chiedevo invece cosa ne pensasse dell’altro: il dominio dei più forti che per alcuni rischia di rendere noiose le gare. Il ciclismo corre veramente questo rischio?
C’è questo rischio, però chi ama lo sport apprezza sempre quelli che riescono a fare imprese del genere. Il problema era presente anche negli anni ‘70 quando c’era un certo Eddy Merckx. È un tema che si ripete, ma non credo che la gente si annoi se Sinner vince tutti i tornei di tennis, né se le corse vengono vinte sempre dagli stessi corridori. È naturale che il ciclismo, come qualsiasi altro sport, diventi più interessante quando ci sono dei duelli, delle sfide che sono incerte. Per questo quando vediamo una sfida tra Pogacar e Vingegaard o tra van Aert e van der Poel è molto più accattivante. Sì, il ciclismo rischia di diventare più noioso se qualcuno riesce a dominare nettamente, però c’è l’apprezzamento dell’impresa, che rimane sempre una cosa straordinaria.
Spesso ho la sensazione che, essendo il peloton molto numeroso, si perdano delle storie minori che sono belle tanto quanto quelle dei grandi fenomeni. Come possiamo evitare che questo accada?
Bisogna raccontarle, bisogna scoprirle. Nel mio caso, ovvero attraverso la telecronaca, bisogna raccontare da dove arriva un’impresa, da dove arriva un corridore, che cosa ha fatto per arrivare a quel punto. Tante volte ci sono delle storie straordinarie, altre un po’ meno, ma comunque tutte danno un’idea di cosa sia il ciclismo, cosa sia uno sport professionistico difficile e di fatica come questo. Ogni corridore può avere una storia fantastica da raccontare, che ti fa rendere ancora più bello questo sport.

Come le sembra, invece, la situazione attuale del ciclismo italiano?
Non stiamo attraversando un bel momento, perché non abbiamo un corridore da corsa a tappe, che possa prendere il posto di Vincenzo Nibali. Abbiamo dei corridori come Tiberi, Piganzoli e Pellizzari che speriamo possano crescere, così come Zana e Frigo. Qualche anno fa si stava meglio, anche perché adesso il ciclismo è diventato veramente mondiale: ci sono ragazzi che sono diventati campioni, che arrivano da ogni parte del mondo. Fino a qualche anno fa, assieme a spagnoli, francesi e belgi, avevamo il predominio nel ciclismo, adesso non è più così. Soffriamo in questo momento anche perché non abbiamo una squadra World Tour, abbiamo meno ragazzini che si avvicinano a questo sport. Abbiamo sicuramente degli ottimi velocisti come Ganna, Milan, Dainese e siamo fantastici su pista. Sono cresciute moltissime le donne, ma per quanto riguarda la strada al maschile in questo momento stiamo inseguendo.
Come se lo immagina il ciclismo del futuro?
Difficile prevederlo. Anche se sono cambiate le biciclette, gli allenamenti, le strade, le squadre, c’è sempre un comune denominatore che è la fatica, l’impegno che serve metterci per avere dei buoni risultati. Le corse importanti saranno sempre più importanti, mentre rischiano di scomparire le corse minori: il piatto forte è dato dalla partecipazione dei grandi campioni, che a loro volta non possono gareggiare sempre e dunque si concentreranno sulle corse più importanti. Anche nelle difficoltà, anche con il mondo che avanza, il Giro d’Italia e il Tour de France, così come la Milano-Sanremo o il Giro di Lombardia, rimarranno sempre nell’immaginario collettivo come grandi corse e saranno più ambite che mai. Per il momento, sono abbastanza ottimista. Certo, se vado a vedere quello che era il ciclismo 40 o 50 anni fa e quello che è adesso, speriamo di poter resistere.
In Song of Myself, Walt Whitman ad un certo punto scrive: “sono vasto, contengo moltitudini”. Quante moltitudini contiene il ciclismo?
Consiglio sempre alle persone di mettersi sulla cima di una salita e di guardare in faccia ogni singolo corridore. Ognuno di loro gli trasmetterà sempre qualcosa di sé, dal primo all’ultimo. Perché la faccia di ogni ciclista parla, soprattutto in salita. Quando poi te ne torni a casa e pensi a quelle facce, a quegli occhi, a quelle smorfie, capisci cos’è una corsa, una tappa, una salita e cosa può darti.
La centrifuga del pavé fiammingo
Ancora prima che iniziasse, almeno un paio di persone si sono interessate sul mio stato di consapevolezza rispetto al fatto che da lì a pochi giorni avrebbe preso il via la Settimana Santa del ciclismo. Santa non solo perché nel mezzo c’è la Pasqua, ma anche perché, a detta di Alberto Bettiol, i corridori sono spesso impegnati a pregare per delle buone gambe. Per chi mastica la lingua sarebbe più corretto dire la Vlaamse Wielerweek, ovvero la settimana ciclistica fiamminga. Effettivamente aggiunge anche più contesto, soprattutto per me che a proposito di masticare e di ciclismo ne ho di movimenti di mascella da fare o, se preferite, di pastasciutta da mangiare. Nel raccontarvi come sia andato uno dei miei tanti battesimi ciclistici, credo sia meglio specificare fin da subito che fino al 26 maggio dello scorso anno ritenevo il ciclismo uno sport noioso. Lo facevo, per giunta, senza avergli dato una vera e propria chance: mai una gara vista in tv o dal vivo, mai una pedalata su strada o sentiero. Finché un venerdì di primavera, che qui dalle mie parti assomigliava più ad un principio di estate, mi sono ritrovata a guardare la diciannovesima tappa del Giro d’Italia - quella da Longarone alle Tre Cime di Lavaredo - con la scusa di voler rivedere dei luoghi in cui non mettevo piede da diverso tempo. Vi anticipo il seguito della storia: da quel giorno credo si possano contare sulle dita di una mano le volte che ho perso una competizione ciclistica trasmessa in televisione, mi sono iscritta a innumerevoli gruppi Telegram del settore, ho declassato Google da browser di ricerca preferito per spendere ore su ProCyclingStats o FirstCycling, ho comprato molti libri che devo ancora leggere e, soprattutto, mi sono perdutamente innamorata del ciclismo. Quest’anno è stato per me, dunque, un susseguirsi di prime volte. La mia prima Omloop, la mia prima Strade Bianche, la mia prima Tirreno-Adriatico, la mia prima Parigi-Nizza, la mia prima Milano-Torino, la mia prima Milano-Sanremo e adesso, appunto, anche la mia prima settimana ciclistica fiamminga.
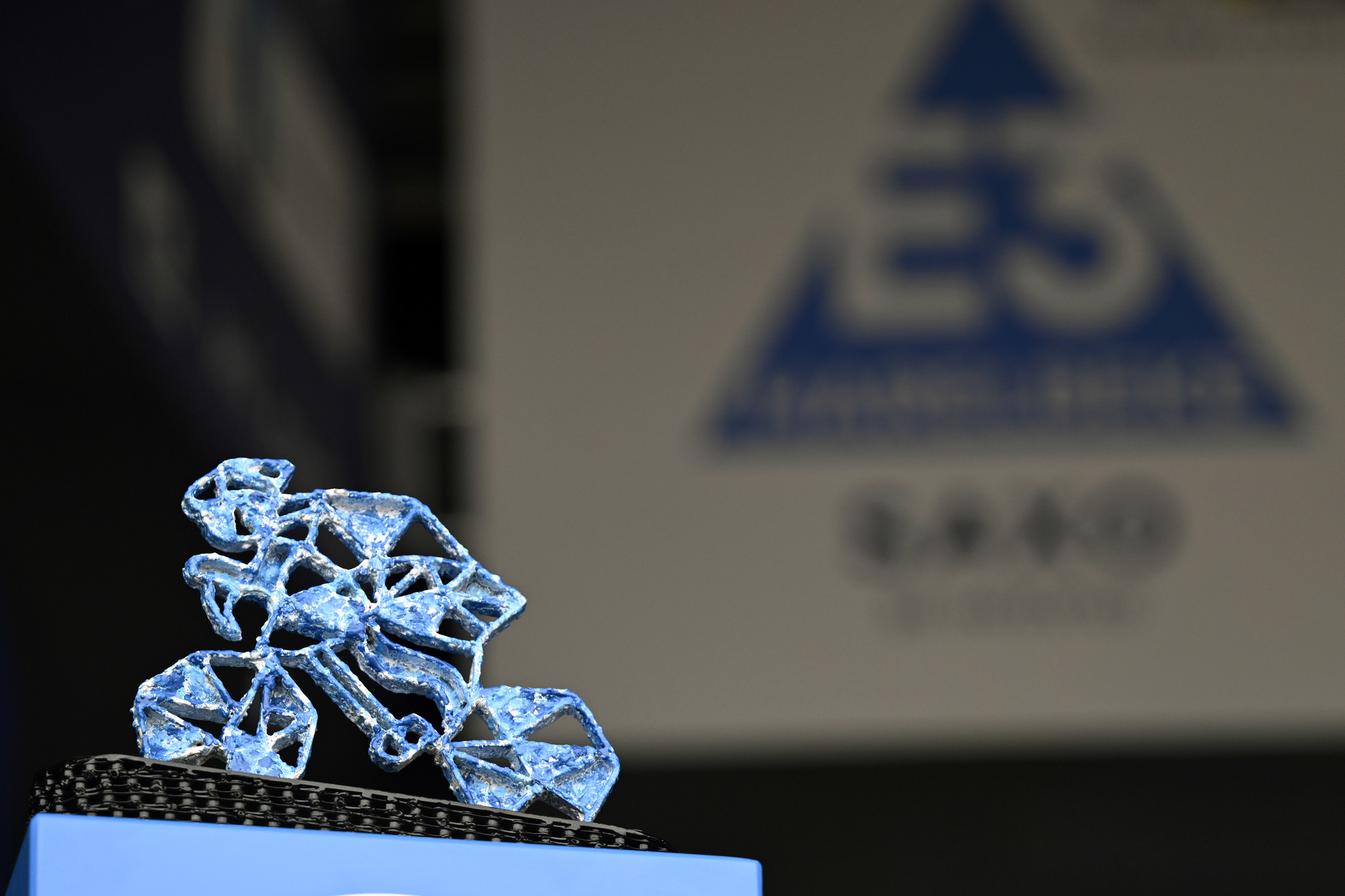
Per una che vive di inizi, soprattutto in questa parte di stagione a me sconosciuta, non poteva esistere altro tipo di approccio alla Settimana Santa se non quello di sperimentare tutte le sue tappe, partendo dalla Brugge-De Panne, passando per l’E3 Saxo Bank Classic, la Gent-Wevelgem, la Dwars door Vlaanderen, il Giro delle Fiandre, la Scheldeprijs e per chiudere la Parigi-Roubaix. Per ora posso già ammettere che la seconda di queste fermate, l’E3 Saxo Bank Classic, mi è piaciuta moltissimo. Che c’entri forse il fatto che è stata una corsa a dir poco folle rispetto a quanto ho visto finora? L’ipotesi merita di essere presa in considerazione. Da quando è stata creata, nel 1958, ha cambiato per ben 5 volte nome. Il primo è stato Harelbeke-Antwerp-Harelbeke: un modo semplice per dire che le prime edizioni avevano un percorso che partiva da Harelbeke, cittadina delle Fiandre occidentali, arrivava ad Anversa e tornava al punto di partenza. È stata una parentesi piuttosto breve, perchè agli inizi degli anni ‘60 anche il Belgio venne coinvolto nella nuova rete autostradale E3, che collega Lisbona a Stoccolma, ed ecco che la gara cambiò nome in E3-Prijs Harelbeke. C’è stato poi il tempo di E3 Harelbeke, come qualcuno la chiama ancora, e E3 BinckBank Classic, per arrivare al nome attuale E3 Saxo Bank Classic.
Girando in lungo e in largo per internet, ho scoperto che l’E3 è l’unica gara della Settimana Santa a non essere organizzata dalla cooperativa belga Flanders Classics. Poteva, però, essere decisamente più fortunata in termini di organizzatori, almeno da un punto di vista comunicativo. Lo dico per certi avvenimenti che definire scivoloni sarebbe un eufemismo. Ve ne cito due, quello che ha avuto più impatto mediatico e quello più recente. Per quanto riguarda il primo, che è avvenuto nel 2015, devo portarvi dietro di un altro piano di anni, ovvero nel 2013: vi ricordate quando, sul podio del Giro delle Fiandre, Peter Sagan ha la brillante idea di allungare una mano per afferrare il fondoschiena di Maja Leye, intenta a baciare sulla guancia il vincitore, Fabian Cancellara? Provò anche a metterci una pezza, offrendole un mazzo di fiori e confermando la poca comprensione del gesto appena compiuto. Un paio di anni dopo, il team della comunicazione dell’E3 ha trovato ispirazione dall’accaduto, sorvolando sul fatto che si trattasse di un episodio di violenza sessuale e di sessismo allo stato puro. L’edizione di quell’anno aveva il seguente slogan che, giustamente, fece infuriare molti: “Who squeezes them in Harelbeke?”. Quando si dice un colpo di genio!
C’è da sorprendersi, dunque, se quest’anno sono stati costretti a ritirare una vignetta omofoba che vedeva protagonista Wout van Aert e che non ho alcuna intenzione di descrivere? Non andatevela a cercare, piuttosto userei quel tempo per riflettere su come l’indignazione per entrambi i fatti si sia esaurita nel giro di poco. Non ci sono stati, per quanto io sappia, grandi cambiamenti nel contrastare il sessismo nel mondo del ciclismo e il silenzio di molti, di troppi pesa come un macigno. Tra nomi e momenti di poca intelligenza che si susseguivano, i ciclisti belgi hanno scritto la storia dell’E3: Armand Desmet fu il primo ad apporre la propria firma, vincendone la prima edizione, mentre qualche anno più tardi il connazionale Rik Van Looy non si accontentò di vincerne soltanto una, ma arrivò alla bellezza di 4 vittorie. Chissà se Van Looy ha guardato l’edizione del 2012 in cui un altro belga, Tom Boonen, ne batteva il record vincendo l’E3 per la quinta volta. A guardare la lista dei vincitori, è abbastanza evidente che i belgi in questa gara ci tengono a non sfigurare, ma negli anni altri nomi di una certa caratura hanno trovato spazio per le loro prodezze, primi fra tutti lo svizzero Fabian Cancellara e l’olandese Jan Raas. Compaiono anche bandierine tricolori nell’elenco per ricordare le vittorie di Guido Bontempi (1988), Mario Cipollini (1993), Dario Pieri (2002) e Filippo Pozzato (2009).

Anche quest’anno il menù, nonché percorso, prevedeva 207,85 chilometri di stradine strette di campagna, puro pavè belga e soprattutto muri, moltissimi muri. Diciassette, per la precisione, di cui almeno tre da tenere sott’occhio: il Taaienberg, il Paterberg e l’Oude Kwaremont. Al passaggio sul primo mi è stato consigliato di essere certa di trovarmi davanti ad un televisore o un computer che trasmettesse la gara, anche in caso di un impellente bisogno di andare in bagno o una catastrofe in corso nelle vicinanze. All’E3 se deve succedere qualcosa, succede lì. Gli altri due, invece, sono l’antipasto, anche se nel senso opposto, di qualcosa di più grande, che arriverà il giorno di Pasqua. Proprio per questo motivo e per la tendenza ad usare la gara come occasione di test per quello vero, c’è chi la chiama il piccolo Giro delle Fiandre. Il Paterberg, comunque, poco prima della gara non ha fatto passare dei giorni sereni all’organizzazione: un cedimento ha messo in dubbio per un attimo la possibilità che l’E3 potesse passare da lì. C’era ovviamente un piano B, ma 300mila euro di lavori finiti appena in tempo hanno evitato di mandare in frantumi i cuori di moltissimi appassionati di ciclismo. Compreso il mio, che temeva già di vedere un E3 e un Giro delle Fiandre in versione geneticamente modificata.
La lista partenti di questa edizione era bella ed interessante quanto il percorso, ma la verità è che non vedevo l’ora di assistere al primo incontro su strada per questa stagione tra Wout van Aert e la maglia iridata, Mathieu van der Poel. Il belga della Visma | Lease A Bike ha conquistato la corsa per due anni di fila e probabilmente sognava di raggiungere Cancellara e Raas agguantando una terza vittoria, per giunta consecutiva, dopo un periodo in altura. L’olandese, invece, che non è andato mai meglio del secondo posto della scorsa edizione, ai microfoni, prima della gara, quasi si è nascosto: poco importa che mi abbia portato sul ciglio della poltrona per un’ora durante la fase finale della Milano-Sanremo, ha detto di avere ancora bisogno di qualche altra gara su strada per trovare la sua forma migliore. Bisogna dire che non è che poi un podio sia fatto solo da due gradini e c’erano effettivamente altri nomi interessanti che mi incuriosivano: i due Visma | LAB, Matteo Jorgenson, vincitore della Parigi-Nizza, e Jan Tratnik, primo a tagliare il traguardo alla Omloop Het Nieuwsblad; Alberto Bettiol della EF EasyPost in una forma stellare a detta della primavera italiana: 1° alla Milano Torino, 5° alla Milano-Sanremo; Matej Mohorič della Bahrain-Victorious, con cui consiglierei di non competere in una gara di un giorno; Mads Pedersen della Lidl-Trek con la testa alla prima Monumento da vincere, ma le gambe comunque da allenare sul pavè belga e un compagno di squadra altrettanto interessante come Jasper Stuyven. Perché poi non sperare in Julian “Loulou” Alaphilippe o Gianni Moscon della Soudal Quick Step? Avrete capito che ci sono dei pro e contro nell’essere dei novellini in questo sport: ci si ferma spesso solo ai grandi nomi, leggendo le liste partenti, ma in compenso si ha grandissima fiducia nei miracoli.

Oramai ho metabolizzato il fatto che la parte iniziale di tante gare nel calendario devo provare ad immaginarla, affidandomi alle dirette testuali di altri. Nell’attesa che iniziasse la diretta, avevo due finestre aperte sullo schermo: il già citato ProCyclingStats e Sporza, con gentile supporto del traduttore automatico di Google Chrome, un’esperienza che merita di essere vissuta anche solo per leggere “i diversi pacchi vengono nuovamente pinzati insieme” quando un tentativo di fuga viene riassorbito dal gruppo. Non la potevo vedere, ma la gara intanto partiva e per nulla piano, perchè il tachimetro ha superato da subito i 60 km/h. Non stavano pedalando da molto quando è arrivata la notizia di una caduta: ero preparata al fatto che l’E3 mi avrebbe colpito per numero di abbandoni, ma appena è comparso il nome di Alberto Bettiol tra gli otto coinvolti avrei preferito sinceramente leggere altro. Speravo che fatto un Giro delle Fiandre se ne potesse fare un altro quest’anno e ci spero ancora. Ma se inizialmente è stato tra i fortunati che sono tornati in sella, anche lui si è dovuto ritirare a poco più di 70 chilometri dalla fine. Ha raccontato dopo la gara di avere un bell’ematoma sul fianco destro e di aver battuto la cresta iliaca: dovrà fare dei controlli e a noi non rimane che incrociare le dita. È andata peggio a Per Strand Hagenes della Visma Lease A Bike, che era partito al posto di un malaticcio Laporte, e Christophe Noppe della Cofidis, portati via in ambulanza.

A riaccendermi ci è riuscito, a 150 chilometri dalla fine, un bel gruppetto piuttosto giovane composto da Emil Herzog, Lorenzo Milesi e Jannik Steimle. Dal peloton, che aveva già più di 20 secondi di ritardo, si sono staccati anche Sander De Pestel, Remi Cavagna, Ivo Oliveira, Jonas Abrahamsen e Jelle Vermoote per andare a riprenderli. Habemus fugam! Ovviamente è arrivata a mettercisi di mezzo anche una leggera pioggia, mentre le strade hanno continuato a rimpicciolirsi: in gruppo non si stava in più di quattro per fila e bastava un minimo singhiozzo per far fermare e ripartire quelli dietro. Quando Moscon ha cominciato a mettersi a tirare come un forsennato, il gruppo ha cominciato ad assomigliare ad un puzzle: i ciclisti erano come pezzi buttati, senza una particolare forma, su un tavolo di asfalto e pavè in attesa di trovare il posto giusto per sognare in grande. Lo sarebbero sembrati ancora di più pochi attimi dopo, perché la maglia iridata aveva deciso di dare la prima accelerata della giornata sul Taaienberg. Mancavano 79,7 chilometri dalla fine e subito mi sono chiesta se non stesse pensando quasi di emulare Pogačar alle Strade Bianche. La differenza tra i due è stata che per Mathieu quella piccola fuga è durata il tempo di rendersi conto che non era il momento giusto, che rischiava di trasformarsi in uno spreco di energie magari utili più tardi. Sul Boigneberg, van der Poel, infatti, ci ha riprovato di nuovo, ma è stato sullo Stationberg che è riuscito a prendere più spazio, seppure con van Aert già subito alla sua ruota. Il gruppo di testa, che si era ben difeso inizialmente da quello che succedeva dietro, ha cessato di esistere. Ce n’era uno nuovo, all’interno del quale il belga e l’olandese continuavano a studiarsi.

È stato il Paterberg a decidere da che parte dovesse pendere questo scontro tra titani: van der Poel è partito, inconsapevole ancora che il quinto tentativo sarebbe stato quello decisivo. Per non lasciarlo andare via, infatti, van Aert ha rischiato ed è caduto. Desiderare troppo la vittoria delle volte è il modo migliore per perderla. Il belga comunque è riuscito a rialzarsi e tornare in sella, ma l’olandese nel frattempo ha preso lo spazio che stava cercando già da decine di chilometri. È diventata improvvisamente una caccia all’uomo: ogni metro, ogni chilometro era una chance per van Aert di rosicchiare secondi. Si è schiacciato sulla bici, ha aumentato la frequenza di pedalata, ha deciso di dare tutto per rimediare all’errore. Van der Poel, nel frattempo, fendeva gruppi di persone che un po’ lo applaudivano, un po’ lo fischiavano. Eravamo pur sempre in Belgio e la gente del luogo, tra cui anche un Eli Iserbyt in incognito, ma nemmeno troppo, preferiva incitare l’altro, non lui. Ogni tanto, girandosi, vedeva ancora van Aert. Data la velocità a cui stava andando il belga, chissà se ha cominciato ad immaginare di essere in una crono non tanto contro il tempo, ma contro l’alieno in maglia bianca davanti a sé. Sul Karnemelkbeekstraat si è infranto ogni sogno del predatore di riacciuffare la preda, scappata dalla sua morsa ancora viva: mentre sfrecciava davanti alla celebre macelleria Van de Walle, Van der Poel aveva ripreso i secondi persi e aumentato il distacco. Il belga aveva capito che era arrivato il momento di gettare la spugna, ancora una volta doveva accontentarsi di stare su un gradino più basso, ma quale? Perchè i giochi non erano ancora chiusi e dietro Jorgenson, Girmay, Narvaez, Stuyven e Wellens si avvicinavano pericolosamente a un van Aert sempre più sfinito. È stato il connazionale della Lidl-Trek, con una pedalata molto più fluida, a riprenderlo. Davanti, a poco più di un chilometro dalla fine, van der Poel si è girato verso l’ammiraglia e ha cominciato ad esultare, alzando un pugnetto in aria. Poi, a pochi metri dal traguardo, si è alzato sui pedali e ha salutato militarmente il pubblico belga, sé stesso e un’altra prestazione spettacolare. È stato lui il primo a tagliare il traguardo di Harelbeke, a sancire una nuova vittoria in una gara di un giorno dopo la SUPER 8 Classic dello scorso anno. Nemmeno Cancellara nel 2013 aveva pedalato da solo così tanto: lo svizzero li aveva staccati tutti a 35 chilometri dalla fine, van der Poel a 43,7. È stato il terzo campione del mondo a vincere l’E3, dopo Jan Raas (1980) e Tom Boonen (2006), il quinto olandese a portarne a casa la vittoria. Van Aert è arrivato quasi due minuti dopo e, a testa bassa, ha lasciato passare anche Stuyven a pochi metri dal traguardo.
Poco prima della premiazione è sembrato di vedere una scena più o meno già vista: nel dietro le quinte non volava una mosca tra Stuyven, van Aert e van der Poel, un po’ come non volava sul divanetto alla fine della scorsa edizione della Milano-Sanremo tra Ganna e i due soliti noti. L’olandese, in compenso, ha provato a inimicarsi ulteriormente il popolo belga, quando ha deciso di non bere nemmeno un sorso del bel bicchierone di birra, che, da tradizione, viene dato ai fortunati finiti sul podio. Neanche una goccia ne è stata comunque sprecata, per gentile concessione di Mathieu nei confronti di un piccolo gruppo di fan che si passava con felicità il liquido bottino. Subito dopo la gara, van Aert ha detto di essersi sentito benissimo, lo aveva capito dalla facilità con cui stava alla ruota dell’olandese. Tutto è stato perfetto fino alla caduta sul Paterberg, che in un secondo momento, a mente lucida, ha valutato come un errore decisamente stupido. Van der Poel è stato, invece, sorpreso da sé stesso, ha ammesso che un livello così alto in una classica non lo aveva mai raggiunto, l’unica cosa che gli si avvicinava forse era la gara dei Mondiali di Glasgow. In pochi hanno il privilegio di tirare fuori paragoni del genere e lui è sicuramente uno di questi.

Vi evito l’elenco di tutti quelli che quel traguardo non lo hanno tagliato: come immaginavo, è un numero spropositato a cui dovrò abituarmi in queste folli gare fiamminghe. In compenso, nella lista di quelli che ce l’hanno fatta, ho trovato un po’ di cose interessanti: per l’Italia c’è stato un bellissimo nono posto di Vincenzo Albanese, ma meritano una menzione anche Luca Mozzato (21esimo) e Matteo Trentin (23esimo); il quinto posto di Matteo Jorgenson aggiunge sostanza alla mia tesi che una volta diventati calabroni, si acquistano dei superpoteri in sella ad una bici; difficile, invece, non essere curiosi di scoprire di più su cosa ne sarà la stagione di Oier Lazkano dopo la bella prestazione all’E3, confermata anche da José de Cauwer di Sporza che lo ha definito un vero “Flandrien”; mentre è chiaro che la Lidl-Trek quest’anno ha decisamente il coltello tra i denti. Ovviamente non me ne vogliano gli altri corridori sopravvissuti, prometto di mettermi in pari con le moltitudini di storie che il peloton di quest’anno contiene. Mi è dispiaciuto, piuttosto, non essere riuscita a vedere le donne divertirsi in questa gara: ai primi di gennaio gli organizzatori dell’E3 hanno annunciato che non si sarebbe tenuta la sua versione femminile, ovvero la Leiedal Koerse. I motivi sono due: un po’ c’entra il calendario, che è diventato abbastanza pieno e ha messo in difficoltà le squadre, non in grado per struttura a coprire più corse contemporaneamente; un po’ c’entrano i soldi, perchè a quanto pare l’organizzazione non ha raccolto abbastanza dagli sponsor. I costi sono aumentati e ovviamente ad essere stata tagliata è la terza edizione della giovane classica femminile. In compenso, quando sono tornata a respirare di nuovo, dopo diversi chilometri e minuti in apnea, dopo classifiche e scrolling compulsivo, mi è sembrato di essere passata come i corridori attraverso la centrifuga del pavè fiammingo. Avevo i muscoli ammaccati dalla tensione, come se assieme a van Aert, alla base del Paterberg, fossi caduta anche io. Ho cercato di levarmi di dosso i tipici “se” e “ma” che la mia mente aveva cominciato a generare nel momento in cui avevo visto la ruota anteriore del belga sancire la fine di ogni speranza di una volata a due fino al traguardo. Sui social media erano tutti d’accordo: homo faber ipsius fortunae ancora una volta. Ma finchè c’è un uomo che cade, si rialza e continua a pedalare, il finale di una gara non è mai del tutto scritto. All’E3 Saxo Bank Classic di quest’anno è andata così, ma la Settimana Santa è appena iniziata. Santifichiamo le feste, santifichiamo i vincitori, santifichiamo gli sconfitti che non smettono mai di provarci.











