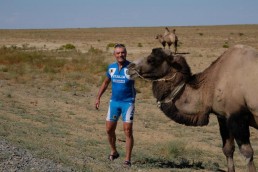La responsabilità di Anna
Non era facile fare quello che ha fatto Anna van der Breggen. I più diranno che i campioni sono capaci di questo: certo, ma resta difficile. Rinunciare ai Campionati Europei di Trento e alla prova a cronometro mondiale perché non al top della forma, all'ultima stagione da professionista, è un gesto che richiede una responsabilità che, talvolta, sotto la pressione di chi sei e di chi tutti si aspettano tu sia, rischia di sfuggire. Se poi fai parte di quella macchina da guerra che è la nazionale olandese ancora di più.
«Correre una cronometro è qualcosa che puoi fare solo se sei al 100% concentrata sull’obiettivo e con una grande motivazione. Una motivazione che io non ho più perché mi sento già molto soddisfatta per le cronometro che ho corso nella mia carriera e mi sono posta degli obiettivi diversi per questi Mondiali: per la mia ultima volta voglio essere io ad aiutare le ragazze che in questi anni hanno sempre corso per me, per aiutarmi a raggiungere i miei traguardi» van der Breggen lo ha spiegato sui suoi canali social proprio negli scorsi giorni.
Van der Breggen, lo aveva raccontato in un’intervista a Velonews qualche mese fa, già da tempo meditava sulla possibilità di ritirarsi dalle corse per allargare la famiglia: «È stato molto confortante vedere l’esempio di atlete come Marta Bastianelli e Lizzie Deignan, che sono tornate a correre dopo aver avuto un figlio. Per gli uomini questo tipo di problema non si pone: possono tranquillamente portare avanti la loro carriera da professionisti e avere dei figli. Per noi donne si tratta di una questione molto importante, qualcosa che ti cambia la vita. Certo si può sempre pensare di tornare a correre, dopo aver avuto un bambino, ma occorre avere una grande motivazione per farlo. In questo momento per me il desiderio di maternità, soprattutto considerando che mio marito è di nove anni più vecchio di me, è il fattore determinante per cui ho deciso di ritirarmi dal ciclismo professionistico».
Il suo obiettivo, appena scesa di sella, sarà quello di aiutare a crescere una nuova generazione di cicliste, infatti Anna vorrebbe salire in ammiraglia come direttore sportivo nel Team SD Worx, la squadra con cui corre ormai da cinque anni. Anche se in realtà la van der Breggen pare già ragionare da direttore sportivo in corsa, basterebbe vedere il lavoro che ha fatto quest'anno alla Liegi-Bastogne-Liegi per Demi Vollering che poi ha vinto quella Liegi. Nessuno spazio per il protagonismo anche in quell'ultima volta.
Apparentemente timida, indecifrabile, non ha mai temuto di sbilanciarsi parlando di ciclismo. Tempo fa ha placato gli entusiasmi per Cherie Pridham, prima direttore sportivo donna nel WorldTour maschile. Non perché non apprezzi Pridham ma perché ritiene che uomini e donne abbiano competenze e capacità diverse e sia un errore esaltare qualcuno solo sulla base del sesso. Così Pridham non è speciale perché donna, lo è perché competente e perché smentisce quella voce, tipicamente maschilista, secondo cui le donne non capirebbero di ciclismo o di sport. Ed è proprio perché le donne di sport capiscono che auspicano un continuo mescolarsi di competenze e di persone, uomini o donne che siano, nel ciclismo, per vederlo crescere forte.
Foto: Bettini
Per tornare in sella
Per Tom Dumoulin non ci voleva, ma la strada non guarda in faccia a nessuno. Qualche giorno fa, un incidente mentre era in allenamento sulle Ardenne ha messo a repentaglio il proseguimento della stagione che per la farfalla di Maastricht sembra davvero terminata qui.
Siamo certi che la frattura al polso, che pure è la causa dell'infrangersi degli obiettivi di fine stagione, dopo che un automobilista l’ha investito, sia, in fondo, il minore dei problemi per Dumoulin che sin da subito si è mostrato molto deluso. «Ero appena tornato, non ci voleva» ha detto e qui dentro c'è già tutto ciò che non serve dire ma che è necessario capire, soprattutto in un mondo come quello sportivo che richiede freneticamente risultati. Il dolore vero è essere nuovamente fermi, bloccati.
A gennaio, Tom Dumoulin aveva scelto di fermarsi a tempo indeterminato «per scrollarsi una zavorra dalle spalle, per capire cosa effettivamente volesse, per scoprire chi fosse davvero l’uomo Dumoulin» spogliato della maschera di campione e di ciclista esemplare. Era tornato con i suoi tempi, in punta di piedi. Era tornato soprattutto a osservare il ciclismo da bordo strada come un tifoso qualunque prima di tornare a far girare i pedali, quasi gli servisse avere una visione d'insieme del proprio sport, quella che si perde quando si è a tutta, concentrati sulla linea d'arrivo. Gli era servito, se è vero che, al rientro, al Tour de Suisse, a giugno, aveva ben figurato e, poco dopo, aveva vinto il titolo nazionale a cronometro.
Mesi in cui tutto era sospeso, perché non basta tornare, bisogna esserne convinti e quando c'è di mezzo la passione, quella che porta un ciclista a scegliere il proprio mestiere, si può sbagliare, si può tornare per paura, non per volontà. Poi il progetto Tokyo 2020 e quell'argento che vale oro. Abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo quando l'abbiamo sentito dire: «Ho avuto seri dubbi, ma ora so che voglio continuare: penso ancora che il ciclismo sia uno sport molto bello». Perché il ciclismo ha bisogno di persone come Dumoulin.
Veniva dal Tour del Benelux in cui era tornato a mettersi in mostra in buone condizioni di forma. Questa caduta non gli permetterà di partecipare alle gare di fine stagione e al Mondiale, gare in cui sperava, ma siamo certi che lo restituirà al suo mondo ancora più forte. Perché a cadere, sia realmente che metaforicamente, si impara col tempo. Come a medicarsi le ferite e ripartire. Tom Dumoulin ha imparato e oggi è certo di una cosa: tutte le cadute gli hanno solo insegnato come rialzarsi. Per tornare in piedi, anzi in sella.
Foto: Bettini
Il morso del Cobra
Lasciatecelo dire: vedere Sonny Colbrelli correre come ha corso oggi, a pochi giorni dagli Europei in Trentino, lascia spazio all'immaginazione. E poco conta che si tratti soltanto del Benelux Tour, dovremmo tornare a entusiasmarci senza fare le pulci a ogni emozione.
Sonny Colbrelli solletica l'immaginazione come ogni ciclista che parte da solo in fuga quando al traguardo mancano ancora molti chilometri e gli altri si stanno studiando. Come ogni "uomo da solo al comando". La sua maglia è verde, bianca e rossa, avrebbe detto molti anni fa Mario Ferretti. Noi lo abbiamo pensato, ve lo diciamo.
Il Cobra che parte ai cinquanta chilometri dall'arrivo di Houffalize insieme al compagno Mohorič e allo svizzero Hirschi e forse potrebbe anche starsene tranquillo e sfruttare la superiorità numerica per portare a casa il risultato. Invece no, si volta verso il compagno di squadra e gli dice: "Uno scatto per uno e lo stacchiamo". Gioco di logoramento.
Lo svizzero non riesce a reggere la frustata di Colbrelli che, ai venticinque dal traguardo, sceglie la solitudine e saluta la compagnia. Hirschi subisce il gioco di Mohorič, un perfetto alleato del fuggiasco: dapprima rallenta il ritmo, provoca, innervosisce, poi, al rientro del gruppetto guidato da Tom Dumoulin rompe i cambi e favorisce l'assolo. Un assolo sudato, senza un attimo di tregua, col cuore in gola, perché dopo venticinque chilometri di fuga vuoi vincere.
"Non avevo mai fatto qualcosa di simile in vita mia. Me lo ricorderò sempre. Spero solo di recuperare per domani". Fra meno di ventiquattro ore avremo la risposta, ma non è ciò che più ci interessa. Già, perché quando Colbrelli decide di inventare non si ferma molto facilmente e giornate così possono solo contribuire ad accrescere l'immaginazione.
La sua e la nostra, perché tra pochi giorni c'è l'Europeo. Non dimentichiamolo.
Andrea ha scelto la libertà
Quel giorno di venticinque anni fa, alla stazione di Monza, Andrea Pusateri scappò dalle mani della madre mentre stava transitando un treno. Aveva solo tre anni e nell'impatto perse entrambi gli arti inferiori, sua madre diede la propria vita per salvarlo. Solo il tempestivo intervento dei medici ha permesso ad Andrea di recuperare la gamba sinistra. Mesi di ospedale e poi il ritorno a casa, dai nonni che l'hanno cresciuto. «Mi hanno insegnato che nella vita bisogna essere felici perché solo la felicità rende liberi. La libertà vera non esiste quando sei triste, deluso o arrabbiato. Devi essere felice per scovarla». Andrea ricorda bene che tanto i nonni quanto lo zio cercarono da subito di avvicinarlo allo sport e oggi capisce perché.
«Le discipline paralimpiche di fine anni ‘90 avevano quasi nulla a che vedere con quelle odierne. Portavano, però, la consapevolezza che nello sport gli ostacoli vanno superati e che non ottieni quello che desideri se non con la tua fatica e il tuo sudore, il tuo talento e il tuo merito». Una consapevolezza che si fa strada col tempo e si espande in ogni scelta. Andrea assiste alle gare in bicicletta di un amico: la bicicletta gli piace, ciò che fa il suo amico lo affascina e non capisce perché non possa riuscire anche a lui ad andare in bicicletta. Ripensandoci oggi ha chiaro come tutte le scelte più importanti della sua vita siano nate così, da un «perché non posso farcela anche io?».
Quella bicicletta nel tempo è diventata un lavoro, ma è alle origini che si spiega tutto. «Ho subito pensato che su una bicicletta, in un gruppo, succede come succede nella vita. Puoi avere tante persone accanto a te, amici o meno, ma, se non sei tu a decidere di salvarti, di concederti una possibilità, nessuno può fare qualcosa per te. Nemmeno la tua squadra, che è poi la tua famiglia, tutte le persone che vorrebbero aiutarti. Senza il tuo permesso, senza il tuo primo passo, non possono fare nulla». Allenamenti su allenamenti, nel 2008 la prima gara a Varese, e, nel 2014, con la prima medaglia in Coppa Europa, la sensazione di avercela fatta.
Questione di attimi, di illusioni perdute e ritrovate. Solo un anno dopo, mentre si allena, Andrea cade e sbatte violentemente la testa per terra. Un'altra corsa contro il tempo, una settimana di coma farmacologico e tutte quelle voci, quelle che per qualche attimo rischiano di farti credere che questa volta è davvero finita. Quasi che la tua storia, fino a quel momento, sia stata troppo bella per essere vera. Raccontatelo ad altri, non ad Andrea che tre mesi dopo, a Maniago, vince la Coppa del Mondo. «Non posso raccontarti quello che ho provato, posso dirti che quella felicità non l'ho mai più provata e mai più la proverò probabilmente. È la felicità di quando capisci che tutto ciò che ti avevano detto è vero, che, se vuoi, puoi farcela. Quasi sempre».
Proprio perché ha toccato con mano la felicità di cui parlavano i nonni, Andrea non accetta altro. Nel 2019 ha lasciato il ciclismo per dedicarsi all'Ironman. «Molte cose sono cambiate, migliorate, certamente. Ma il mondo del paraciclismo è un mondo che non può andare avanti così. Eravamo considerati sportivi di serie D, non so di chi sia la colpa, probabilmente di più persone e tutti dovremmo fare qualcosa per cambiare». Con la disabilità ha sempre avuto un rapporto sereno, forse anche per il suo carattere: ama ridere, scherzare e del giudizio degli altri si disinteressa. «Ogni persona è diversa e deve vivere la disabilità come crede. Il ciclismo, lo sport, possono aiutarti a tirare fuori quella parte di te che in certe situazioni resta schiacciata dagli eventi».
Tutto in una cornice relativa perché così è la vita, spiega sorridendo. Andrea lo ha capito guardando i suoi due cani: «Mi hanno cambiato perché ho visto che le cose che davvero contano sono poche. Certe volte, immersi nella quotidianità, ce lo scordiamo e finiamo per vivere male. Anche lo sport è una parte della vita e tale deve restare, senza esasperazioni».
La felicità diversa dei fratelli Hayter
Al Tour of Norway, qualcosa è scattato nella mente di Leo Hayter. Classe 2001, team Dsm, fratello minore di Ethan, giovane talentuoso di casa Ineos Granadiers, Leo ha a lungo patito, silenziosamente, la scelta di mollare tutto per dedicarsi allo sport, come se nella vita non ci fosse nient'altro. Un lungo processo di accettazione, per ritrovare la felicità di pedalare. Il 21 agosto, l’ha scritto su suo account Twitter: «La giornata di oggi mi ha ricordato perché lo faccio. Finalmente ho avuto la sensazione di gareggiare e non solo di essere un’appendice della corsa. È la prima volta che mi succede dal 2019».
Ethan e Leo hanno condiviso ogni cosa sin da ragazzini. Fin da quel pomeriggio in cui i genitori li accompagnarono a un centro estivo nei pressi di un Velodromo: una scelta casuale per permettere ai ragazzi di divertirsi e tornare al lavoro. Ethan aveva già la fisionomia di un ciclista, Leo no e, a dire il vero, nemmeno gli interessava. Racconterà anni dopo che, fino a quel momento, tutti i pomeriggi della sua infanzia li trascorreva sul divano, mangiando e giocando alla play station. Non aveva il fisico da ciclista, tanto meno la mentalità. Avrebbe solo voluto essere un ragazzo qualunque.
Una scelta non scelta che dopo qualche anno inizia a portare i primi risultati. Leo Hayter vince la prima corsa da junior, ad Assen, e subito pensa ad un colpo di fortuna. «Ho sempre creduto che, se non fossi arrivato da solo, non avrei mai vinto nulla. Sarebbe stato un gioco da ragazzi per chiunque battermi» spiega a The British Continental. È lui il primo a non credere nelle proprie possibilità, forse perché non ha la grinta che serve per primeggiare, forse perché le persone al suo fianco non ci credono. Nella British Cycling Junior Academy, fino a quel momento, per tutti, è “il fratello minore di Ethan”. Quest’etichetta pare non infastidirlo e lui stesso ammette che Ethan ha capacità superiori alle sue, ma le scelte di vita, spesso più delle parole, rivelano davvero ciò che sentiamo.
Tutto inizia da un volo per partecipare a un training camp con il Team Sunweb: Leo mangia qualcosa e subito dopo inizia a stare male. Ciò che sembrava non interessargli diventa importante: vuole dimostrare di valere e non dice nulla di quel malessere. Fa due giorni di prova mangiando solo pane scondito e si sente in forma, in salita pedala come non mai. Scelta scellerata: nel suo fisico c'è qualcosa che non va, solo qualche settimana dopo, in un allenamento, cadrà a terra completamente svuotato.
Per guarire serve tempo, ma quei giorni hanno cambiato qualcosa in Leo. Ha la certezza di volere qualcosa in più e sa che nell'Accademia britannica sarà condannato a restare “il fratello minore di Ethan”. Sa di non avere il fisico ideale per lavorare in pista e dice ai genitori di voler passare nel team Dsm. Difficile convincerli, come se quel figlio fosse sempre troppo giovane per decidere in autonomia, come se la sua strada dovesse essere per forza quella di Ethan, come se il suo fosse un destino già scritto. Ma per la prima volta Leo Hayter sceglie la strada che davvero desidera e improvvisamente non è più solo “il fratello minore di Ethan”.
Non è mai stato facile e mai lo sarà, anche se la Coppi e Bartali corsa assieme dai due fratelli ha risvegliato l'entusiasmo del pubblico e degli addetti ai lavori, come le storie a lieto fine. Quella di Leo e Ethan Hayter non è una storia a lieto fine perché, forse, le storie a lieto fine come tutti le immaginiamo nemmeno esistono. Nemmeno quando Ethan vince il Tour of Norway e Leo ritrova se stesso. La storia dei fratelli Hayter è la storia di chi ha capito che non bisogna credere a chi cerca di convincerci che se non siamo i primi non valiamo nulla. Non è vero per lo sport e, soprattutto, non è vero per la vita. Non hanno senso i paragoni o i confronti perché siamo completamente diversi, anche da un fratello, e nessuno può cambiare questa realtà. Ma la felicità se ne frega dei confronti e arriva lo stesso. Chiedetelo a Leo Hayter.
Foto: Bettini
Il decalogo di Magnus Cort
Ai 350 metri dalla vetta del muro di Valdepeñas de Jaén, Magnus Cort Nielsen ha avuto ancora una volta la certezza di non essere uno dei tanti. Proprio mentre il mondo gli crollava addosso e la gravità sembrava la più bizzarra delle leggi. Magnus, dopo una giornata in fuga, contro tutto e tutti, era un corpo trascinato verso il basso, incapace di fare la più normale delle cose in sella a una bicicletta: andare avanti. A destra, poi a sinistra e di nuovo a destra per non cadere a terra. Lo sorpassano Roglič e Mas, lo sorpassano López e Haig, lo sorpassano ventiquattro corridori e passano quarantanove secondi prima che arrivi in vetta. Lo speaker inizia a incitarlo, lo stesso fa la gente. Un mondo che si capovolge e ti riempie di lividi quando sei il più vulnerabile e non te lo meriteresti. «È ingiusto» direbbero i più.
Magnus Cort ha imparato da troppi anni che imprecare è inutile. Da quell'isola aspra quasi quanto una strada che sale. A Bornholm, quarantamila anime, nel mar Baltico, c'era posto solo per l'immaginazione. La stessa che ha convinto il danese ad andarsene a sedici anni per fare il mestiere del ciclista.
Veloce, certo, non a caso vorrebbe somigliare a Peter Sagan, ma non solo. A Magnus piace complicarsi la vita e, col tempo, ha avuto la certezza che le migliori possibilità provengano proprio da lì. «Forse in condizioni normali non posso battere i migliori, ma esistono anche la pioggia, il freddo e il vento...». Quasi una provocazione, come le fughe dell'uomo del nord. Ha vinto tappe alla Vuelta, la corsa degli scalatori: quest'anno persino all'Alto de Cullera, proprio mentre Roglič lo stava raggiungendo, una settimana fa. «Ai 150 metri ho temuto, per fortuna non mi ha ripreso». Parole che sembrano quasi uno sberleffo a sentirle oggi.
Orica, Astana e Education First, senza rincorse, rispettando lo scorrere del tempo che riconosce la fatica, il sacrificio. Poi, nei momenti liberi, si prende una tenda, gli sci, si imballa la bicicletta e si parte in spedizione sui Pirenei. Oppure si torna a Bornholm, dalla famiglia, e si va in campeggio. Magnus Cort ha un decalogo di regole: usa solamente ciò che hai, impara una cosa semplice alla volta, rispetta le regole, non portare mai due cose uguali, quando fa notte guarda un film sotto le stelle e riposati su un materassino che hai già provato a casa. Soprattutto non partire mai con scarpe che tu non abbia già indossato: in mezzo al bosco non potrai cambiarle.
Ha in mente una spedizione sul Kilimangiaro e vorrebbe fare bene alle Classiche del Nord. Ci riuscirà? Chissà. Di certo Magnus Cort è riuscito a inventarsi una vita neanche lontanamente immaginabile. Per questo è Alvento, come chi vede ciò che manca e, invece di lamentarsi, lo inventa.
Foto: Jered Gruber
La Transibérica e il rispetto per la fatica
Il cielo di Bilbao era impazzito il 14 agosto, come a prendere a schiaffi chiunque vi si trovasse sotto: pioggia fitta, vento, nuvole nere e sole. Bruno Ferraro era lì per partire per la Transibérica, gara di ultracycling attraverso la penisola iberica. Qualche mese prima, Bruno si era rotto la clavicola cadendo in bicicletta e, quel giorno, si accontentava di partire perché aveva temuto di non arrivare proprio sotto le bizze di quel cielo che fissa l'oceano.
La partenza è alle ventuno nella piazza del museo Guggenheim. Ad attendere gli iscritti circa tremila chilometri. Al dislivello si prova a non pensare, fa quasi paura. «Mi è sempre piaciuto guardarmi attorno - racconta Bruno - e non ci ho mai rinunciato anche quando ho gareggiato. Credo sia uno spreco, se si ha la fortuna di pedalare». Così di Bilbao ritorna subito la parte vecchia della città e il fiume che l'attraversa. Di ogni passaggio in un luogo, Bruno ha custodito qualcosa in più della fatica.
Devono trascorrere ben ventidue ore per arrivare al Mont Caro, a sud della Catalogna. «La vegetazione si dirada e l'ossigeno viene meno. La cima è a 1.441 metri, ma potresti pensare di essere a oltre duemila metri». Fa caldo e le falesie che si stagliano ai fianchi di Ferraro accrescono la sensazione di soffocamento. La scelta, però, è chiara: «Ho deciso che non mi sarei mai fermato a dormire prima di una salita. Meglio partire in pianura al mattino e faticare di più la sera». A Ordesa, la luce del tramonto rimpalla sui minerali delle rocce e confonde. «L'ultimo tratto era su terra, ghiaia. Ricordava il Colle delle Finestre. L'aria era quella dei Pirenei, le gambe iniziavano a chiedere tregua».
Il Deserto di Bardenas Reales arriva a mezzogiorno del giorno seguente. «In Spagna l'escursione termica è molto elevata. Di notte si sta bene e al mattino l'afa è tollerabile, qualche tempo dopo sarebbe stato impossibile pedalare in mezzo a quelle guglie di sabbia e argilla che ti seccano la gola solo a guardarle». Dopo Albarracìn, “un borgo toscano trapiantato in Spagna”, Bruno arriva alla Sierra De Guadarrama. «Avevo prenotato una camera a Segovia: sono arrivato dopo la mezzanotte e sette ore a pedalare all'insù, dovevo dormire. Prima di ripartire ho fatto un giro nel centro di Segovia, circa venti minuti». Verso il confine portoghese, si sale a Peña de Francia. «Sembrava il Mont Ventoux. C'era solo la luna a rischiarare i contorni di un monastero in cima. Pedalare di notte è una scoperta».
Bruno fa rifornimento dalle stazioni di servizio e dai benzinai, solo tramezzini: per un giorno ne servono quattro. «Bastava il sapore del formaggio di capra per darmi coraggio o il profumo dei pomodori accanto alla fesa di tacchino per risollevarmi il morale. In avventure di questo tipo scopri che basta ben poco». Da lì non manca molto. El Morredero “è un trampolino pronto per lanciare una navicella nello spazio”, la salita più dura che Ferraro abbia mai visto. «Rampe da togliere il fiato e pochi tornanti. Ho abbassato la testa per non vedere. Dall'altro versante, le ombre delle pale eoliche che si accostavano alla luna sembravano quasi la sceneggiatura di un film di fantascienza».
I laghi di Covadonga, in Asturia, sono l'ultimo sforzo, prima di tornare a scendere verso Bilbao. «Il primo cartello lo si vede a ottanta chilometri dalla città: è un'illusione. I continui saliscendi sono velenosissimi. Ero quarto, dietro di me c'era Simon de Schutter ma ormai non poteva più riprendermi. Non mi sembrava vero». Sono passati più di sette giorni, è domenica 22 agosto. A vincere è Ulrich Bartholomos, un ragazzo che sorride anche quando è stremato.
C'è una morale particolare in questi uomini della fatica. Justinas Leveika, lituano, arriva terzo e a Bruno dice subito che senza quelle due ore di sonno in più lo avrebbe ripreso. «Gli ho detto che rispetto la fatica e che non lo avrei mai superato a così poco dal traguardo. Mi sarei accostato al suo fanalino e saremmo arrivati assieme. Terzo o quarto non cambia nulla, il rispetto, invece, fa sempre la differenza».
Bruno, stasera, atterrerà in Italia e tornerà a guardarsi in giro, con calma, serenità, cercando di ricordare ogni dettaglio. In fondo, è questo a contare.
Foto: Transiberica
Marco Villa guarda già a Parigi
«Forse l'idea di dover affrontare i detentori del record del mondo ha fatto tremare le gambe anche alla Danimarca» scherza Marco Villa, CT della nazionale azzurra su pista. Spiega così la medaglia d'oro olimpica nell'inseguimento, dopo cinque anni a dimostrare il valore del lavoro fatto. Villa, da uomo di sport, sa bene che la concretizzazione, in questi casi vale quanto la fantasia. «Nelle prove degli ultimi giorni i tempi delle nostre avversarie erano migliori, non so se sia stata tattica. La Danimarca, poi, negli ultimi due anni aveva quasi sempre fatto meglio di noi». Se dei timori potevano esserci, al quartetto sono sempre arrivati stimoli, risposte e razionalizzazioni. «Vero che i danesi si sono praticamente riportati sugli inglesi in semifinale, altrettanto vero, però, che hanno potuto sfruttare la scia. Lo stesso discorso vale per le qualifiche: molte squadre hanno avuto il vantaggio di potersi basare su dei tempi di riferimento. Ai ragazzi ho detto questo la sera prima».
Marco Villa ha da sempre le idee chiare: le analisi, per essere utili, vanno fatte prima. «In partenza eravamo in vantaggio e non era un caso: sulle nostre tabelle era previsto. Sapevamo che avremmo potuto perdere qualcosa nel finale. Uno era il punto: dovevamo restare dai sette ai nove decimi, perché quei tempi sono nelle gambe di Ganna». Poi gli azzurri hanno festeggiato come chi ha avuto ragione a discapito dei momenti difficili. «La caduta di Lamon durante le qualificazioni a queste Olimpiadi è stato uno dei momenti più difficili, oltre alla pandemia. Si è sempre in tanti e i posti sono pochi. Saremmo stati pronti anche lo scorso anno, lo abbiamo dimostrato».
Villa spiega, razionalizza, chiarisce e soprattutto chiede. «Dopo lo scratch a Elia Viviani ho detto solo: “Elia, cosa sta succedendo?”. Mi ha detto che le gambe c'erano, la testa no. Era stato irriconoscibile. La risposta se l'è data da solo, io non posso entrare nella sua testa o nelle sue gambe. La tempo race non è mai stata la sua gara, ha fatto un'eliminazione stupenda e una grande corsa a punti». Per questo il bronzo di Tokyo vale come l'oro di Rio, perché viene da un periodo difficile. Per questo, se parla di madison, il CT è certo che la coppia Viviani-Consonni abbia molto da dire. «Simone quella mattina non stava bene e una gara di sessanta chilometri non puoi improvvisarla. Sulla base delle circostanze non puoi costruire un'analisi per il futuro. Succede e basta».
Intanto, via verso Parigi 2024. «Il gruppo è rodato con uomini di esperienza, allo stesso tempo ho dimostrato che la strada per i giovani è sempre aperta. Si guardi Milan. È uno stimolo per loro e anche per gli altri perché se non si danno da fare sono sopravanzati». Ora basta chiacchiere, a Parigi mancano solo tre anni.
Dal Lago di Como alla Via della Seta in bicicletta
Dario Piasini ricorda bene il giorno in cui sorprese suo padre ad osservarlo di nascosto mentre giocava a calcio. «Sono nato nel 1950 e in quegli anni, subito dopo la guerra, lo sport non aveva lo spazio che ha oggi. Mio padre temeva portassi via del tempo allo studio o al lavoro così restava indifferente, però lo vedevo che di nascosto veniva alle partite. Credo che, in fondo, fosse felice». Il giorno in cui molti anni dopo gli hanno proposto di andare da Como a Pechino in bicicletta ha accettato senza pensarci troppo perché con lo sport è sempre stato in debito. «Non avevo più la potenza dei giovani, ma la voglia di conoscere e di mettermi alla prova era la stessa. L'età è spesso un ostacolo mentale».
È il 2005: 14000 chilometri, dal lago alla Via della Seta, quindici ciclisti e tre furgoni. «Se foravamo cambiavamo la ruota, non avevamo nemmeno la camera d'aria. Siamo partiti il 25 aprile, ci sono voluti quattro mesi». Ogni giorno una tappa, pochi giorni di riposo e un traguardo fisso. «Non ho mai avuto dubbi. Chi ha l'opportunità di viaggiare in questo modo è un privilegiato. Non è stato tutto facile: nel deserto non c'erano telefoni, mezzi di comunicazione, bastava una peritonite per lasciarci la pelle». Un medico li avverte: «Dal punto di vista ciclistico non avrete problemi, a livello psicologico invece sarete logorati, la tensione e il nervosismo vi porteranno a litigare per sciocchezze». Piasini queste discussioni le ricorda, come ricorda le lezioni di storia e geografia del professor Corbellini e le confessioni di quelle sere.
«Ci siamo detti cose che non avremmo detto a nessuno: ci liberavamo delle tensioni e delle preoccupazioni di casa, del lavoro. La fatica ti porta a capire». Si scordano facili pregiudizi: a Teheran inizialmente si fanno foto di nascosto, temendo il giudizio della popolazione, poi si scopre che proprio gli abitanti non vedono l'ora di farsi fotografare con questi avventurieri. «Se viaggi per sport, senza mettere in ballo idee politiche o religiose, troverai persone pronte ad accoglierti e aiutarti ovunque» chiosa Piasini.
Dalla Costa Dalmata a Samarcanda, al Kirghizistan e alla sua capitale che ricorda la Valtellina, dalla foto sul confine con i militari cinesi e le guide kazake, alle oasi verdi e al Fiume Giallo, a monasteri e Buddha dormienti, sino all'ingresso a Pechino, scortati dalla polizia. «Ho mangiato scorpioni e bacarozzi fritti e non erano neanche male. Solo ogni tanto ci concedevamo la pasta con la bottarga, visto che un ragazzo sardo aveva messo nel camion quattro chili di bottarga fresca alla partenza».
All'arrivo si vuole tornare ma dispiace perché quel mondo parallelo si sta esaurendo e nella vita di ogni giorno certe sensazioni non si ritrovano più. «Se chiudo gli occhi, rivedo tutto. Capita, ma è ancora presto. Sento di avere la forza per altre avventure. Verrà il giorno in cui dedicarsi al ricordo, ora voglio vivere».
Quello che Ten Dam ha imparato
Laurens Ten Dam ha corso diciassette anni nel professionismo, eppure ha conosciuto davvero la bicicletta solo qualche settimana fa, quando è arrivato secondo nella Unbound Gravel, duecento miglia unsupported intorno a Emporia.
«Prima di partire per Gravel Locos ho detto a Ted King che doveva essere pazzo a correre a tre settimane dalla rottura della clavicola - spiega a Cyclingnews - Giusto un paio d'ore per capire come tutto fosse diverso».
In realtà, che questo fosse un altro volto del ciclismo, l'ha visto appena ha forato e ha dovuto sistemare da solo la ruota. «Sei abituato a chiedere aiuto ma sei da solo e per ripartire devi arrangiarti».
In Kansas un ragazzo è andato a bussare a una fattoria per chiedere una pompa per gonfiare una ruota, l'olandese l'ha guardato stupito: «Credi possano aiutarti? Quante pompe vuoi che possiedano?». Nel mentre si sfidava con Ian Boswell per il primo posto. «Seccato per il secondo posto, ma ringrazio la bicicletta per tutte le avventure che mi fa vivere e le persone che mi fa conoscere».
Ten Dam vorrebbe raccontare tutte le storie dei folli che corrono queste gare. «Posso raccontare a mio padre cosa ho fatto, però non potrà mai saperlo davvero se non lo proverà. Porterò qui i miei amici: saranno in fondo al gruppo e arriveranno ultimi, ma vivranno questa esperienza e torneranno felici».